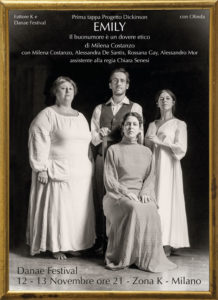Masculu e Fìammina è un monologo che utilizza il potere dell’immaginazione per trasportare lo spettatore nella storia di Peppino, uomo semplice di un paese imprecisato della Calabria. Basta poco. La scenografia è minimale: un cerchio di neve, una lapide innevata, la fotografia della mamma, la colonnina su cui si siede l’uomo, non prima di avervi appoggiato un cuscino bianco. Tutto è bianco e grigio. Bianca la neve, bianco il cuscino, grigie la lapide e la foto, grigi i capelli di Peppino. Un solo puntino rosso a scaldare il quadretto: la rosa che ripone con cura davanti alla lapide.

Saverio La Ruina ha scritto un testo che arriva al cuore, lo stringe, lo accarezza, lo scalda e lo solletica suscitando persino il riso tra i toni tristi e malinconici dominanti. Non mancano nemmeno slanci di gioia nei “ricordi belli a metà” che il protagonista condivide d’inverno con Nina, sulla panchina sotto le fronde degli alberi e che ripete alla mamma, nel cimitero. Il tutto è recitato con una coloritura dialettale che affonda le radici nel retroterra linguistico e culturale dell’attore-autore, comprensibile anche alle orecchie meno avvezze alle parlate del sud.
La mamma di Peppino non c’è più, ma è come se fosse presente davanti a lui col “vestito fiorato, che mette il buon umore”. La vediamo anche noi, per come lui le parla. Se la immagina in viaggio verso il paradiso, forse ormai in coda con la valigia in mano ad aspettare il suo turno per parlare con San Pietro, che vaglia all’ingresso: “Tu sì. Tu no. Tu aspetta.”
Nessuna lacrima per la madre, solo una normale, quotidiana chiacchierata che poi si trasforma in confessione. Con lei si confida, si scusa e la ringrazia. Per la prima volta le dice apertamente di essere omosessuale. E’ una liberazione. Si scusa per non aver avuto il coraggio di dirglielo prima, anche se, ne è certo, lei l’aveva già capito da tempo e mai gliel’aveva fatto pesare. La ringrazia per ciò che in vita gli ha detto, per le parole pacate che ha usato, per il rispetto che ha nutrito nei suoi confronti: il rispetto è qualcosa che si ha, non si impara a scuola – dice Peppino-Saverio – l’istruzione non c’entra, così come non c’entra l’ignoranza. Alla mamma è bastata la terza elementare per averlo.
Peppino inizia quindi a ripercorrere le tappe del difficile percorso di auto-accettazione, tramite cui ha preso coscienza della propria omosessualità, passando poi per i primi amori, le delusioni, gli insulti, l’adesione a gruppi comunisti degli anni ‘70 (come Lotta Continua o Collettivo Karl Marx) che portano in paese un’ondata di libertà, ma anche di ipocrisia, fino ad arrivare ad un Segreto ancora più grande, dalle tinte macabre, che lo consuma da anni e per cui gli “piange non solo la faccia, ma il corpo intero”.
La storia di Peppino è fatta di immagini vivide. In un flusso di coscienza Saverio La Ruina fa riaffiorare una serie di episodi che intrecciano la sua vita con quelle di altri personaggi:
Nina, l’amica uscita dalla Banda della Magliana
Gino, il primo omosessuale del paese
Enzo, il compagno di scuola dal dolce sorriso
Pina, “che è partito masculu ed è tornato fìammina”
Angelo, di nome e di fatto
Alfredo, il grande amore da Treviso
Vittorio, amico schietto e provocatorio
Saro e Marietto, i travestiti fatti Santi
Alcune delle loro storie finiranno in tragedia, segnando profondamente l’animo di Peppino. Non tutto però è frutto della fantasia dell’autore. Nella Mezz’ora con l’attore (momento del Festival dedicato al confronto con gli artisti) Saverio La Ruina ci rivela che molti dei personaggi sono stati costruiti a partire da esperienze personali reali di conoscenti e da cronache.

Dolcezza, gentilezza, rispetto, autenticità sono concetti a cui l’attore-autore sembra tenere molto e che tornano più volte nel monologo, dando vita a spunti di riflessione, come quello sulle parole. Più che le persone, sono le parole che fanno paura, sia a chi le dice, sia a chi le riceve. Omosessuale, checca, frocio, fru fru, ricchione dette con tono spregiativo sottintendono l’idea di invertito, anormale, malato, diverso dall’uomo in quanto essere umano. Così accade che per chi ama una persona dello stesso sesso sia difficile riconoscersi come tale davanti ad uno specchio, frenato da pregiudizi sociali. Peppino racconta di essere riuscito a definirsi omosessuale, nel momento in cui ha realizzato che il principio che porta ‘nu masculu ad amare ‘na guagliuna è lo stesso che porta ‘nu masculu ad amare ‘nu masculu. Ecco che allora Peppino trova istanti di libertà ed autenticità stando nudo, solo, in spiaggia dove si vedono “solo pìetre, pini e ginestre” poi “mare e cielo” e“di nuovo pìetre, pini e ginestre”.
Ma Peppino è stanco. Si convince che Angelo, di nome e di fatto, ha ragione: in un paese come il loro avrebbero dovuto aspettare almeno cent’anni perché le cose cambiassero. Ha sentito che un uomo ibernato nella neve può rimanere intatto per anni e anni, allora si siede di fianco alla tomba della madre e sullo scontrino della rosticceria scrive: “svegliatemi quando il mondo sarà un po’ più gentile”, magari un mondo in cui la parola “ricchione” vorrà dire semplicemente “uomo dalle grandi orecchie”. E aspetta, con le mani nella neve.
Alessandra Minchillo
Festival delle Colline Torinesi XXII Edizione
Teatro Astra –18 giugno 2017
Masculu e Fìammina
di Saverio La Ruina
regia Saverio La Ruina
con Saverio La Ruina
musiche originali Gianfranco De Franco
collaborazione alla regia Cecilia Foti
scene Cristina Ipsaro e Riccardo De Leo
disegno luci Dario De Luca e Mario Giordano
audio e luci Mario Giordano
organizzazione Settimio Pisano
produzione Scena Verticale