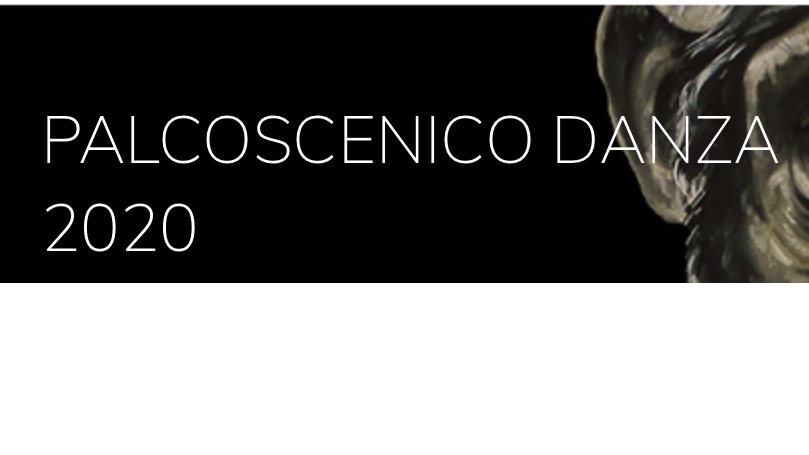“Sventurata la terra che ha bisogno d’eroi.”
(Bertolt Brecht)
Secondo il pensiero cinese ogni cosa è divisa tra lo Yin (nero) e lo Yang (bianco), e rappresenta un equilibrio, un dosaggio fluido e misterioso di queste due componenti. Lo Yin e lo Yang sono energie opposte e complementari che in costante interazione reciproca producono il mutamento e costituiscono l’essenza delle cose e della vita. Lo Yin per poter esistere deve contenere una parte di Yang e viceversa.

L’anima buona del Sezuan è una “parabola” cinese, così come la definì lo stesso Brecht quando nel 1938 cominciò a scriverla, che riprendendo il concetto dello Yin e dello Yang, parla dell’impossibilità di poter vivere pienamente il “bene” senza portare a difesa di esso un alter ego cinico di “male” che fa scelte impopolari per proteggere il bene dall’egoismo e dall’avidità circostante.

Elena Bucci e Marco Sgrosso, come eredi del teatro di Leo de Berardinis, sono consapevoli che scrivere per il teatro è dare spazio al non detto, che sperimentare nuovi linguaggi può coincidere con la riscoperta della tradizione, che disgregare un classico in funzione di un suo riuso può significare ritrovare e rifondare un mito come quello della commedia dell’arte per coniugare la comicità sfrenata con la sacralità di una “parabola” antica, come in questo caso, divenuta un “classico” a malincuore di Brecht, per sospendere il personaggio o la maschera in funzione di un graduale e contraddittorio rivelarsi. Una partitura densa di sonorità inaspettate tra le escursioni nell’oralità popolare e nella lingua letteraria, per le scelte pluristilistiche e dialettali in funzione antimimetiche. In scena, sempre seguendo l’insegnamento di De Berardinis, svelati i misteri dei rumori e della musica effettuati dal vivo dal bravo musicista/rumorista Christian Ravaglioli.
Lo spettacolo è corale: 9 attori in scena a interpretare a rotazione tutti e i 21 personaggi del dramma di Brecht. Lo spettacolo dura più di 2 ore ma il ritmo è serrato e non c’è sosta né per gli attori né per gli spettatori, decisamente rapiti dalla bravura di questi performer che hanno saputo trovare nella “maschera” della commedia dell’arte una sintesi equilibrata tra teatro occidentale e teatro orientale. Tradizioni nostrane si mischiano alla sacralità rituale di un teatro apparentemente distante e il tradire questa forma facendone nascere una nuova è il modo migliore per restituire l’epicità del lavoro brechtiano.

I corpi hanno la proprietà della danza, e il canto e il ballo non entrano mai veramente in scena ma divengono quasi la naturale conseguenza di un ritmo organico che viene mantenuto per tutto lo spettacolo. Si ha come l’impressione che gli attori e le scenografie, quelle edicole che ricordano le postazioni dei drammi sacri, concorrano insieme a formare un unico organismo vivente, con un suo respiro, con una sua personalità, con una sua anima combattuta tra il bene e il male. Su tutto un alone di divinità beffarda che guarda in disparte e sorniona e che non ha nulla a che vedere con le tre divinità venute da chissà dove alla ricerca di quell’anima buona. Quelle divinità infatti, come gli altri personaggi, sono funzioni anch’esse che concorrono alla creazione di quell’organismo unico. No, la divinità sorniona è data da quel disco di metallo sospeso nel cielo al centro del palco, come un gigantesco occhio del Grande Fratello. Richiamo immediato al Gong orientale che veniva usato come strumento per il richiamo e il rilassamento totale dell’anima. Ma che ricorda anche più nostranamente la Luna di Ciaula, che rischiara con incredibile stupore un’anima priva di consapevolezza.
Alla fine dello spettacolo, questo gigante buono, costituito dal torace di quelle impalcature con i colorati attori a rappresentare i vari stati d’animo, sembra sedersi stremato e dichiarare nell’epilogo lo spasimo della sua disfatta:
«Deve cambiare l’uomo? O il mondo va rifatto? / Ci vogliono altri dei? O nessun dio affatto?».
Ma, poi, ciò che conta è il compito affidato agli spettatori in quanto cittadini: constatato che «siamo annientati, a terra, e non solo per burla!», non «v’è modo di uscir dalla distretta / se non che voi pensiate fin da stasera stessa / come a un’anima buona si possa dare aiuto, / perché alla fine il giusto non sia sempre battuto».

Durante gli applausi finali si ha come l’impressione che, in questo spettacolo vissuto come organismo vivente, alla fine si ritrovino a battere all’unisono insieme ai cuori degli spettatori e degli attori anche un po’ quelli di Brecht e De Berardinis.
Nina Margeri
DI BERTOLT BRECHT / TRADUZIONE DI ROBERTO MENIN
PROGETTO ED ELABORAZIONE DRAMMATURGICA ELENA BUCCI, MARCO SGROSSO
REGIA DI ELENA BUCCI / CON LA COLLABORAZIONE DI MARCO SGROSSO
CON ELENA BUCCI, MARCO SGROSSO, MAURIZIO CARDILLO, ANDREA DE LUCA, NICOLETTA FABBRI, FEDERICO MANFREDI, FRANCESCA PICA, VALERIO PIETROVITA, MARTA PIZZIGALLO
DISEGNO LUCI LOREDANA ODDONE / MUSICHE ORIGINALI ESEGUITE DAL VIVO CHRISTIAN RAVAGLIOLI / CURA E DRAMMATURGIA DEL SUONO RAFFAELE BASSETTI / MACCHINISMO E DIREZIONE DI SCENA VIVIANA RELLA / SUPERVISIONE AI COSTUMI URSULA PATZAK IN COLLABORAZIONE CON ELENA BUCCI / SCENE E MASCHERE STEFANO PEROCCO DI MEDUNA
UNA COPRODUZIONE CTB CENTRO TEATRALE BRESCIANO – ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE / COLLABORAZIONE ARTISTICA LE BELLE BANDIERE