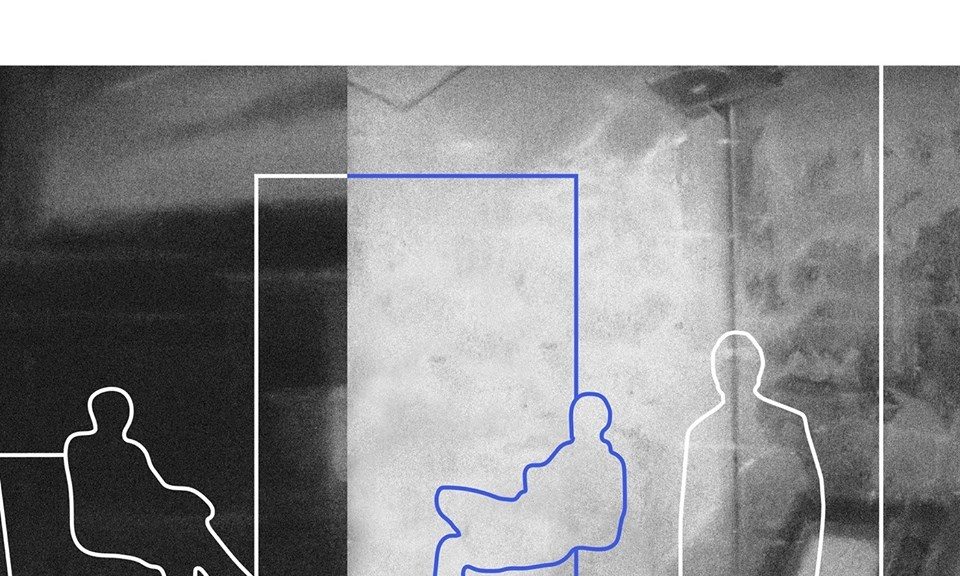Due opere moderne, brevi e senza arie, costellano la serata del 16 maggio al teatro Regio di Torino: Il segreto di Susanna, del veneziano Ermanno Wolf-Ferrari, datata 1909 e La voix humaine, di Francis Poulenc, la cui prima rappresentazione risale al 1959. Cinquant’anni le separano, ma non solo. Una è in stile comico, l’altra in stile tragico, una è italiana, l’altra è francese. Tuttavia la produzione dell’Opéra Comique di Parigi, in coproduzione con Les Théâtres de la Ville de Luxembourg e Opéra Royal de Wallonie, ha scelto di farle circuitare insieme, rappresentandole nella stessa serata, con il medesimo allestimento e la medesima cantante, la formidabile Anna Caterina Antonacci, nei due ruoli di soprano.
Il segreto di Susanna è una irriverente lezione di costumi, in pieno stile primonovecentesco, un intermezzo in atto unico, di un comico ben innescato, che strizza l’occhio alla frizzante musicalità di Mozart (che l’autore amava) e che risveglia quella sarcastica propensione al riso propria del Rossini di due secoli precedenti (che, non si può negarlo, se la si possedesse oggi, troverebbe una marea di frivolezze da schernire). È un misunderstanding tutto avanguardista quello del conte Gil, che scambia il vizio del fumo della giovane moglie, Susanna, per un’infedeltà amorosa: il libretto dipinge il tabagismo come l’amante della modernità, in una perfetta caricatura salottiera memore della stagione settecentesca. Tre sono i personaggi, il conte Gil (Vittorio Prato), Susanna (la Antonacci) e Sante, il servitore muto (interpretato da un simpatico Bruno Danjoux). Ai lussuosi interni déco, e ai bellissimi abiti anni Dieci, che ci si aspetterebbe dall’opera di Wolf-Ferrari, le scene di Antoine Vasseur sostituiscono un piccolo alloggio fintamente elegante, in stile terzo millennio, che vuole economizzare tempi e costi dei cambi scena. Anche la seconda rappresentazione, infatti, si avvarrà del medesimo alloggio, che, ruotando, trasferirà il personaggio femminile dal salotto, al bagno, alla camera da letto, alla cucina. La piccola scena sacrifica un poco i movimenti dei personaggi, ma l’opera si fa apprezzare nella sua semplicità, senza pretese.

La voix humaine è l’adattamento musicale di un celebre monologo teatrale che Jean Cocteau scrisse negli anni Trenta. Francis Poulenc, suo amico, nonché membro del Gruppo dei Sei, adotta una partitura assolutamente moderna, in bilico tra forti tensioni emotive e lirismo tragico, sulla quale si innesta una voce sopranile che deve fronteggiare stili di interpretazione vocale eterogenei e difficili pause e cambi ritmici che è lei stessa a dirigere. La protagonista infatti, unica presenza sul palco per l’intera rappresentazione, intrattiene una drammatica conversazione telefonica con il suo fidanzato, il quale si allontanerà progressivamente dalla sua amata, riagganciando il telefono alla fine del dramma. L’autore stesso inserì un’indicazione particolare nel libretto: “l’intera composizione deve sprofondare nella più grande sensualità orchestrale”. Tuttavia la forza della Antonacci, ci sembra, traspare da un’ottima tecnica vocale e da un solido controllo interpretativo che non sfociano mai nella sensualità auspicata da Poulenc. La cantante, infatti, supera i 50 minuti di monologo apparentemente senza fatica, concedendosi un solo sorso d’acqua a metà della pièce.
A scopo informativo comunichiamo che recentemente lo storico sovrintendente del Teatro Regio, Walter Vergnano, che in 19 anni tanto ha fatto per consacrare la celebrità dell’istituzione a livello internazionale, ha dato le dimissioni. Con lui hanno lasciato anche il direttore musicale, Gianandrea Noseda, e il direttore artistico, Gastón Fournier-Facio. Ad essi sono subentrati William Graziosi alla sovrintendenza e Alessandro Galoppini alla direzione artistica. Preso atto di questi grandi cambiamenti, avvenuti molto rapidamente, e rivolgendo un caloroso ringraziamento al lavoro svolto da Vergnano per la città di Torino, noi, da semplici spettatori del Teatro Regio, ci auguriamo che la sua altissima qualità non ne risenta nel corso dei prossimi anni.