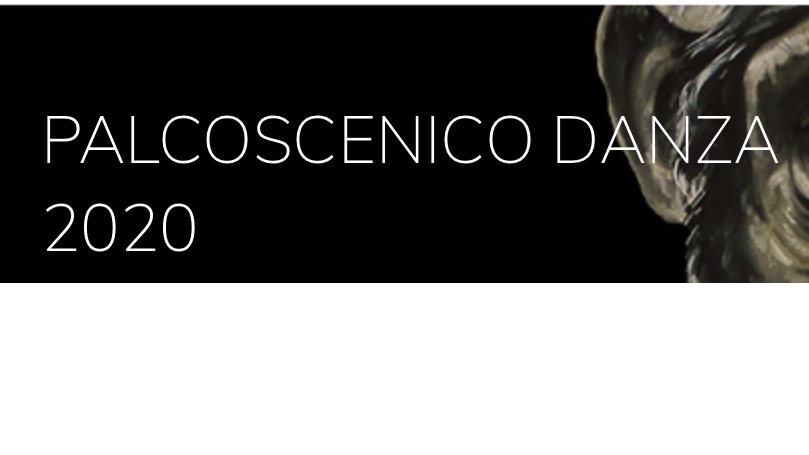La storia del popolo ebraico è una storia in viaggio, una diaspora che dalle origini continua fino ai giorni nostri. Migrazione e dannazione, conducono il popolo ebraico in tutto il mondo; la dispersione come loro condanna, esilio trasformato in forza, che si trasforma in un agglomerato ammassato di cadaveri nei ghetti, nei treni, nei lager nazisti. Morte, e di nuovo dispersione. Cenere. Una storia intrisa di religione, l’attesa di un Salvatore, di un Messia, ma anche il dubbio dell’esistenza di Dio, durante il supplizio delle violenze ai loro danni, il dubbio dell’essere il popolo eletto.
Continua la lettura di Dio ride – nish Koshe, moni ovadiaPALCOSCENICO DANZA 2020
Definito come eclettico, ricco, e danzato, il programma di Palcoscenico Danza è stato presentato mercoledì 15 gennaio presso il teatro Astra, casa e cuore artistico sia della fondazione TPE che del lavoro di Paolo Mohovich, direttore artistico e pioniere di questa rassegna che si prospetta da subito un contenitore di tanta italianità ma con una mano tesa a numerose realtà estere.
Continua la lettura di PALCOSCENICO DANZA 2020ZIO VANJA
Si apre il sipario.
La scenografia è ridotta a una grande incubatrice, molto simile a una serra ma al posto dei fiori, dentro, lotta per la sopravvivenza una famiglia.

MANGIAFOCO
L’allungamento del naso in Pinocchio è solitamente raccontato in termini morali, legato alla riprovazione verso il proferire bugie; ma sollevandosi da questo orizzonte, si potrebbe anche dire: Pinocchio è colui che, raccontando fole o fantasie, subisce una trasformazione fisica: e non è, questa, una delle possibili condizioni o definizioni dell’attore?
Ecco dunque che gli avvenimenti dei tre capitoli del Gran Teatro dei Burattini nel Pinocchio di Collodi detengono il ruolo essenziale di rivelatore della natura burattinesca di Pinocchio: e le grida con cui Arlecchino e gli altri burattini interrompono la recita nel momento in cui lo scorgono tra il pubblico segnano il momento del riconoscimento, dell’appartenenza di Pinocchio a quel mondo, in una sorta di misterioso ritorno a casa. E in quel Teatro, messo alla prova da Mangiafoco, l’enorme e pauroso burattinaio, che minaccia di bruciare Arlecchino in sua vece dopo averlo graziato dalla medesima fine, Pinocchio si propone come eroe tragico, come legno da ardere, adeguandosi perfettamente e naturalmente, per dirlo con Giorgio Manganelli dal suo Pinocchio: un libro parallelo, al “mondo, le leggi, il linguaggio del Gran Teatro”: è il momento, sempre Manganelli dixit, in cui “Egli ha incontrato se stesso, e si è riconosciuto. E si è salvato.”
Continua la lettura di MANGIAFOCOSI NOTA ALL’IMBRUNIRE (SOLITUDINE DA PAESE SPOPOLATO) – LUCIA CALAMARO
È la solitudine, in tutte le sue sfaccettature, a fare da protagonista in Si nota all’imbrunire, scritto e diretto dalla drammaturga Lucia Calamaro ( anche autrice dell’omonimo libro ) con la produzione di Silvio Orlando e della moglie Maria Laura Rondanini.
Continua la lettura di SI NOTA ALL’IMBRUNIRE (SOLITUDINE DA PAESE SPOPOLATO) – LUCIA CALAMAROPREMI UBU 2019
Anche quest’anno abbiamo assistito al consueto appuntamento di consegna dei Premi Ubu, ossia il più importante riconoscimento teatrale del panorama italiano. Il 16 dicembre scorso, presso il Piccolo Teatro di Milano, si è tenuta la quarantaduesima edizione del premio, condotta da Cinzia Spanò e Graziano Graziani con l’accompagnamento musicale di Francesca Morello. La serata è stata trasmessa radiofonicamente da Radio 3 ed è stata seguita da gruppi d’ascolto sparsi in tutta Italia.

Teatro Regio: Carmen di Bizet
Sono state molte le donne frutto del genio poetico che hanno popolato l’immaginario collettivo occidentale. Sicuramente una fra queste è Carmen di Bizet, tratta dalla novella di Prosper Mérimée. Al Teatro Regio di Torino, sotto la direzione di Giacomo Sagripanti, questo personaggio ritorna con la sua intensa drammaticità ad affascinare gli spettatori.
Lo zoo di vetro – Leonardo Lidi
In un mare di polistirolo si trova una casa. Al suo interno, collocate in mezzo ad arredi di color pastello, una donna e una ragazza. Clown. A lato, una figura ignota ha il volto coperto da una scatola di cartone; rimarrà seduta in disparte per tutto il primo atto.
Entra un altro pagliaccio, ricorda un Pierrot. Si chiama Tom e racconta la sua storia. Le sue ultime parole animano le figure nella casa.
Continua la lettura di Lo zoo di vetro – Leonardo LidiFUTURE MAN – spellbound contemporary ballet
Sentiamo l’esigenza di capire, dare un senso a tutto quello che osserviamo: fuori, dentro accanto al nostro corpo. Non sempre il significato emerge ad una prima visione, e senz’altro “Future man” necessita di più sedute per poterne cogliere particolari necessari alla comprensione della narrazione, che a volte si fa elusiva per lasciare spazio ad un movimento stimolante per l’occhio dell’osservatore.

Tosca al Teatro Regio
Una prima apprezzatissima quella di Tosca, andata in scena al Teatro Regio di Torino il 15 ottobre: il pubblico in fervore ha abbandonato la sala soltanto dopo uno scrosciante applauso di circa dieci minuti.