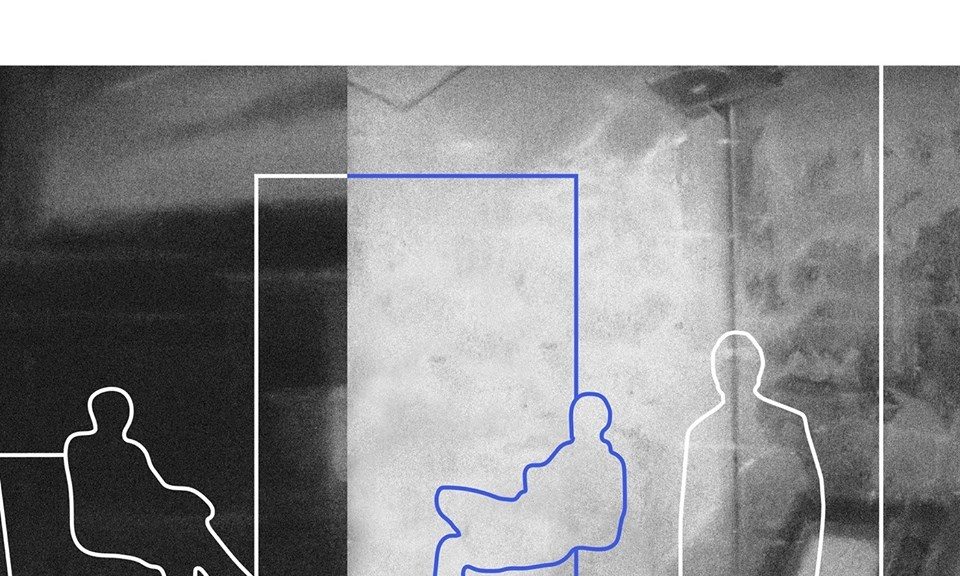Il nuovo direttore artistico di Torinodanza, Anna Cremonini, già presidente della commissione consultiva danza del MiBACT, ha presentato giovedì scorso al Teatro Carignano la nuova stagione del festival. L’edizione 2018, che si terrà come di consueto fra l’autunno e l’inverno di quest’anno, si svolgerà all’insegna di un’apologia dell’amore: Dance me to the end of love è infatti il motto che la identificherà. Con l’immaginazione e la fascinazione, il festival si propone quale “galleria d’arte – scrive la Cremonini – in cui artisti e spettatori si confrontano sui grandi temi del nostro presente” e dove “perdersi in un labirinto di emozioni e sentimenti”.
Dal 10 settembre al 1 dicembre Torinodanza festival presenterà 18 spettacoli, 34 rappresentazioni, 10 prime nazionali, 6 coproduzioni e 16 compagnie ospitate, provenienti da 8 diverse nazioni, confermando la sua vocazione internazionale, nonché una particolare attenzione alle eccellenze italiane. Si augura inoltre di avere una forte incidenza sulle diverse fasce di pubblici fornendo un’app dedicata con cui consultare il calendario e acquistare i biglietti, un’agevolazione di prezzo per chi viene a Torino con Italotreno, una navetta che collega la fermata Lingotto della metropolitana alle Fonderie Limone.
Vediamo brevemente l’offerta del programma, considerando che un’anteprima del festival è già andata in scena in questi giorni alle Fonderie Limone: Betroffenheit di Crystal Pite e Jonathon Young. Ad inaugurare la stagione saranno due spettacoli del maestro belga della danza contemporanea, Sidi Larbi Cherkaoui, (divenuto “artista associato” di Torinodanza per il prossimo triennio), Noetic e Icon, il 10 settembre al Teatro Regio. Segue, dal 13 al 16 settembre, il primo di due spettacoli di circo, Famille Choisie della Compagnia Carré Curieux, in partenariato con il progetto Bruxelles En Piste. Al Teatro Carignano, il 14 e il 15 settembre, sarà presentato in prima assoluta Bach Project, una serata che nasce dalla collaborazione artistica tra Torinodanza, MITO settembre musica e Aterballetto e che prevede un classico di Jiří Kylián, Sarabande, accostato al nuovo lavoro di un giovane coreografo italiano, Diego Tortelli, intitolato Domus Aurea. Inoltre il 15 settembre al Cinema Massimo verranno proiettati, per la rassegna Jiří Kylián, Filmmaker, i film diretti dallo stesso coreografo Scalamare (2017), Schwarzfahrer (2014) e Between Entrance & Exit (2013). Nella stessa occasione Kylián converserà con il pubblico, coordinato da Sergio Trombetta. Il 17 settembre il Teatro Carignano ospita un progetto di Marinella Guatterini, RIC.CI, dedicato alla ricostruzione di storiche coreografie italiane degli anni ’80 e ’90, che per quest’occasione riporterà in scena Erodiade – Fame di Vento (1993 – 2017), un’opera del 1993 nata dalla speciale collaborazione tra Julie Ann Anzilotti e Alighiero Boetti. Il pluripremiato The Great Tamer del greco Dimitris Papaioannou sarà alle Fonderie Limone di Moncalieri il 20, 21 e 22 settembre e allo spettacolo farà da cornice la video installazione Inside, ideata e diretta dallo stesso coreografo, alle OGR – Officine Grandi Riparazioni, dal 20 al 30 settembre. L’israeliana Sharon Eyal, proveniente dalle fila della Batsheva Dance Company, con Gai Behar, presenterà OCD Love e Love Chapter 2, rispettivamente il 29 e il 30 settembre, alle Fonderie Limone. Il secondo spettacolo di circo, di nuovo inserito nel progetto Bruxelles En Piste, è La Vrille du Chat, con la coreografia di Cruz Isael Mata, in scena dal 5 al 7 ottobre al Teatro Astra in prima italiana. Un progetto molto particolare è invece VERTIGINE, il risultato di un anno di lavoro sui territori di montagna tra Torino e Chambéry che hanno visto gli artisti Michele Di Stefano, Marco D’Agostin e Chloé Moglia creare tre spettacoli, (rispettivamente Parete Nord, First Love e La Spire) direttamente nei territori di Bardonecchia e di Pragelato. Gli esiti verranno presentati alle Fonderie Limone di Moncalieri fra il 12 e il 14 ottobre. Nell’ambito dello stesso progetto confluiranno due incontri fra artisti e sportivi: il 13 ottobre con Michele Di Stefano, Alessanro Gogna e Alberto Re e il 14 ottobre con Marco D’Agostin e Stefania Belmondo. Inoltre La Spire andrà in scena anche il 28 luglio in Piazza De Gasperi a Bardonecchia e Michele Di Stefano presenterà il suo Ortografia il 4 agosto nella Baita Chesal della Frazione Melezet di Bardonecchia. Il 16 ottobre Pompea Santoro presenterà, attraverso i suoi ballerini, un excursus sui ruoli di Mats Ek da lei interpretati durante la sua carriera, al Teatro Astra. Alle Fonderie Limone debutterà il riallestimento di uno storico spettacolo di Mario Martone del 1982, Tango Glaciale, il 18 e il 19 ottobre, a cura di Raffaele Di Florio e Anna Redi, sempre inserito nel progetto RIC.CI. Il 20 e il 21 ottobre alla Lavanderia a Vapore andrà in scena il solo Néant di e con il canadese Dave St-Pierre. Salia Sansou, coreografo del Burkina Faso, presenterà il suo Du Désir d’Horizons il 25 e 26 ottobre ancora alle Fonderie Limone. Chiuderà la stagione Alain Platel con il suo ultimo spettacolo, Requiem pour L. La specificità fondamentale del programma si riassume in una evidente tendenza multidisciplinare che si prefigura di amalgamare teatro, danza, musica, nuovo circo, in una fecondazione creativa tra generi differenti.
Da segnalare, infine, l’intenzione di valorizzare il network che alimenta le realtà coreutiche locali e nazionali di cui la nostra danza e la nostra progettazione si alimentano enormemente. Torinodanza Festival, con Romaeuropa Festival e il Festival Aperto – I Teatri (ma potremmo citarne molti altri) si propone di far emergere dall’ombra questa importante rete e sfruttarne al meglio le potenzialità, alla luce del giorno.
Il festival, che la Cremonini eredita da Gigi Cristoforetti, il quale si è intanto trasferito a Reggio Emilia presso l’Aterballetto, è un vero e proprio “gioiello”: anche i rappresentanti delle istituzioni (tra le altre Compagnia di San Paolo, Intesa San Paolo, Città di Torino, Regione Piemonte, MITO Settembremusica) ne riconoscono il prestigio e il valore strategico. Siamo sicuri che il triennio 2018-2020 sarà altrettanto valido quanto quelli che l’hanno preceduto.