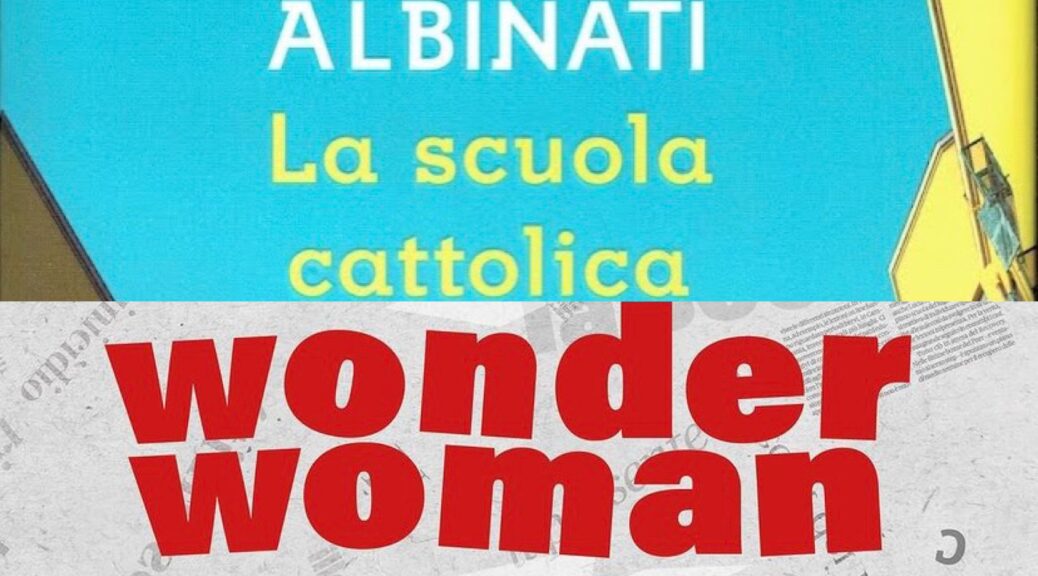<< Dì la verità ma dilla obliqua>> così si apre la presentazione del 16 maggio del Festival delle Colline Torinesi, giunto alla sua 29 edizione, con una mostra alla Fondazione Merz, dal riflesso apollineo, una pala sacra situata in un luogo che sembra essere una chiesa, panchine vuote, candele bruciate ormai spente e dentro la pala lapidi distrutte, epigrafi con nomi, volti e foto differenti. Luci e ombre nuovamente si incontrano e si scontrano per restituire una visione, quanto più realistica e profonda del mondo di oggi.
Continua la lettura di 29 Festival delle Colline Torinesi- Sergio Ariotti e Isabella LagattollaArchivi tag: teatro astra
Cassandra- il potere
Avete mai provato a far dei passi all’interno di una mente umana? No? Ebbene, al Teatro Astra con Cassandra è possibile farlo.
Dietro le quinte sono allestite le tribune, le nostre tribune, quelle del popolo troiano. Il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo e della sua scenografia, luci e suoni ci portano in un ambiente onirico, attraversato da voci flebili ed emozioni strazianti.
Continua la lettura di Cassandra- il potereEdipo Re- Andrea De Rosa
“Abbracciare l’irrazionalità, più che altro l’ignoto, l’unico rapporto che può avvicinarci agli dei è la follia”
Platone
Un’impronta rimane sul vetro, come nell’anima, come sul cuore, senza far respirare i tessuti, nella smania di imparare l’arte di vedere le cose nascoste, soffochiamo ogni battito di sincera verità.
Pannelli di plexiglass, pannelli dorati, fari antichi che proiettano una luce calda, quasi rovente. La scenografia di Daniele Spanò è metallica, direi trasmetta un richiamo spaziale, simbolo di un lungo viaggio che si consuma durante il suo stesso percorso. Edipo, interpretato da Marco Foschi è come una navicella che arrivata troppo vicina al sole, brucia e si dissolve. Tiresia, portatore di profezie, colui che intimorisce l’animo umano e ne svela ogni fragilità. Cosa si è disposti a fare per non imbattersi nel proprio destino? Per mutarlo e cambiarlo a nostro piacimento? Tiresia è interpretato da Roberto Latini, che incarna anche Apollo, un Apollo rivisitato, un Apollo rock. Personaggi sapientemente inseriti nella drammaturgia dal regista, nonché direttore artistico del Teatro Astra, Andrea De Rosa. Apollo, dio obliquo, dio della luce, colui che funge da guida appellandosi alla ragione, senno che il cuore rifiuta, rendendo cechi gli occhi di qualunque essere umano, la cui forza, è inevitabilmente sottratta dalla verità. Aletheia è la parola chiave, una verità fatta di reminiscenze che attende solo di uscire allo scoperto, come una nascita. Edipo Re indaga e svela la tragedia della verità, attraverso i legami, materni e fraterni nonché amorosi ma anche attraverso il significato del potere di cui Creonte mette a nudo l’essenza. Uno spettacolo che mette in mostra il fato, un destino ineluttabile che l’uomo incontra specialmente quando cerca di sfuggirgli. La voce è la protagonista indiscussa della pièce teatrale, le corde vocali del coro composto da Francesca Cutolo e Francesca Della Monica vibrano forti e decise, voci dotate di un’amplificazione divina, i lamenti del coro appaiono indecifrabili, sono forse gemiti o grida? Sono strazianti urla di nascita o di vita sottratta? Domande a cui lo spettatore è chiamato a rispondere, collocando i suoni che sente in base alla propria interpretazione del dolore, della disperazione e della paura, sentimenti noti a tutta l’umanità seppur in modo differente per ognuno. Una sedia, rosso sangue è posta in primo piano, Edipo si mostra raramente in volto, le spalle sono ciò che lo spettatore vede per la maggior parte del tempo, anche noi siamo Edipo, anche noi siamo chiamati a vedere la verità con lui. Giocasta, interpretata da Frédérique Loliée, è un personaggio che seppur principale, risulta talvolta messo in secondo piano come ogni madre, inconsapevolmente, fa col proprio figlio: confessioni e rimpianti si slegano come nodi di uno stesso filo, ingarbugliato nel gomitolo della verità. La peste, antenata del Covid, viene richiamata come punizione divina all’ingiustizia, condannati, noi esseri umani ad una fragilità che non possiamo contrastare se non accettandola. Distanza, rabbia, paura e solitudine, le questioni irrisolte della vita ritornano indietro, come un boomerang, nella disperata ricerca della pace.
Parlando con i protagonisti
Andrea De Rosa, Regista
Edipo e Giocasta, madre e figlio , marito e moglie per patto politico, un rapporto di condivisione e non di seduzione, nulla avviene per caso è Apollo a disegnare questo percorso ma chi è Apollo? Apollo è un personaggio che io ho inventato, come Tiresio, poichè per me è sempre esistito, è colui che porta la luce e che pone la verità in obliquo, così che non possa accecare. Edipo Re è lo spettacolo su cui è stata costruita l’intera stagione “Cecità”, non vedere non è solo un limite, talvolta è anche un vantaggio. Con questo spettacolo in particolare abbiamo indagato sul concetto odierno di verità comparandolo al concetto di verità per i Greci.
E’ Edipo Re un’opera fatalista?
Apollo lascia le scelte, sono gli stessi uomini a decidere quali prendere, decretando così il proprio destino.
Qual è il significato dei pannelli in scena?
L’idea dei pannelli è nata nel lockdown, quando arrivano questi eventi a cambiare il corso della storia, ci si chiede il perché ed è la stessa domanda a cui Edipo Re si sottopone con l’arrivo della peste a Tebe.
A quale parte di voi stessi avete rinunciato per interpretare al meglio i vostri personaggi?
Fabio Pasquini, Creonte
Più che rinunciare a qualcosa, l’abbiamo aggiunta, io personalmente ho portato con me la paura, il risentimento, la stessa sensazione di impotenza, mettiamo tanto di noi nella complessità dei personaggi.
Qual è stato il vostro rapporto con questa tragedia?
Frédérique Loliée, Giocasta
Per me il rapporto con la tragedia greca di Andrea De Rosa è stato scioccante, indagare la verità è stato folgorante. La tragedia è per me il primo stupore, ciò che ti lascia attonito.
Quale è l’importanza della voce , interagendo in un Edipo archetipico e atipico?
Francesca Della Monica, Coro
Ogni spettacolo dovrebbe essere un concerto di voci, liberare la voce dalla sua identrofia espressiva permette di lavorare sul binomio mutos/vogos e così abbracciare la voce e la parola. Un connubio perfetto tra verbale ed extraverbale, tra voce della storia e voce del muto.
Rossella Cutaia
MARCO CORSUCCI – LE MIE PAROLE VEDRANNO PER ME
Uno sguardo interno e amplificato
Nell’ambito della stagione 2023/24 del TPE Teatro Astra è stato presentato un lavoro di ricerca sullo sguardo in relazione alla cecità, tematica che attraversa i 25 spettacoli selezionati per questa stagione.
Le mie parole vedranno per me nasce dalla proposta di Andrea De Rosa, direttore del TPE, a Marco Corsucci e Andrea Dante Bernazzo, giovani talenti del teatro contemporaneo, di indagare il tema della cecità attraverso la loro attenzione verso la percezione visiva e il ruolo delle immagini, già intrapresa nei precedenti lavori.
Continua la lettura di MARCO CORSUCCI – LE MIE PAROLE VEDRANNO PER MEWonder Woman
SIAMO IL GRIDO ALTISSIMO E FEROCE
DI TUTTE QUELLE DONNE
CHE PIÙ NON HANNO VOCE
Questa è la storia di una ragazza, come di altre migliaia, peruviana, giovane e ingenua, come dovrebbe essere ogni ragazza della sua età. Etichettata con il soprannome “vichingo”, per le sue forme mascoline dicono, adescata. derisa, stuprata e poi abbandonata, dagli stessi tre, forse quattro ragazzi. Non ricorda, è sola, sanguinante e lacerata, raggiunge la stazione di polizia, vuole denunciare. Altri uomini la attendono, varcata la soglia, è di nuovo etichettata, adescata, derisa, interrogata, costretta a ricordare ciò che avrebbe voluto dimenticare per sempre, poi, abbandonata.
La platea si spegne della luce di accoglienza che illuminava il teatro, una dolce musica accompagna i riflettori sopra le nostre teste che inaspettatamente si riaccendono, ricominciando ad illuminarsi di una luce pura, abbagliante che si fa sempre più intensa, sembra il sol levante, ho la sensazione che una nuova alba stia per ergersi inesorabile nel cielo. Passi, falcate per meglio dire, scandiscono un ritmo deciso, si percepisce un’energia viscerale e travolgente che spezza il religioso silenzio creatosi tra il pubblico curioso. La vista spodesta l’udito come senso predominante, quattro paia di scarpe rosse, lucide, ci si pongono davanti, attraversando da destra tutta la platea. Quattro donne, disposte di fronte a noi, vestite di tessuti tinti di nero, mi appare in contrasto con tutta quella luce, quasi divina, questo colore sembra spiccare come simbolo di fede e lutto, di autorità e fragilità, di oblio. Non ci sono quinte, non c’è nessun palcoscenico, dei fili rossi con dei microfoni all’apice sono accuratamente disposti dinanzi alle attrici, dietro di loro invece, quasi ad una spanna dal fondale, si intravedono quelle che sembrano essere collane. Resta tuttavia la luce, la protagonista indiscutibile ed insostituibile della scenografia, una scelta inusuale e forte. Ogni attrice prende il suo posto, inizia il primo monologo, vengono pronunciati articoli della costituzione e raccontate storie, gridate a gran voce, l’emozione è travolgente, vibrano le corde vocali delle donne come una viola che finalmente spicca in un concerto. Un’altra voce si intreccia alla prima, poi tutte e quattro, solidarietà e solitudine vengono veicolate perfettamente in una retorica polifonica pulita e precisa, quattro voci che ne diventano una soltanto e poi quattro di nuovo. La potenza della musica, un linguaggio senza confini, questa è la scelta di Antonio Latella e Federico Bellini, due uomini che hanno lavorato con le donne e per le donne che ora, prima di essere persone, sono super eroine, donne raccontate come “amazzoni, donne senza una mammella significa, nate da uno stupro per essere forti ed indomabili”. Lo spettacolo teatrale Wonder Woman, presentato con coraggio a Torino l’11 gennaio 2024, si immerge in una narrativa intensa e scomoda che tocca quindi tematiche cruciali della società. La vicenda rivela il lato oscuro dell’ingiustizia sociale.La scelta di affrontare tali questioni attraverso il teatro si configura come una strada importante per prevenire l’oblio collettivo e dare voce alle vittime spesso trascurate. Il regista, seguendo una tradizione educativa che risale all’Antica Grecia, trasmette un messaggio potente attraverso l’opera teatrale.
Nonostante la polifonia, la rappresentazione soffre forse di una recitazione monodimensionale delle giovani attrici. Sebbene la storia affronti temi tragici, la mancanza di una trasformazione drammatica può lasciare lo spettatore, sia esso uomo o donna, poco coinvolto emotivamente.
La storia, sebbene tragica, potrebbe risultare più coinvolgente se drammatizzata in modo più completo. Wonder Woman si presenta come un tentativo coraggioso di affrontare questioni sociali spinose attraverso il teatro, anche se la performance avrebbe potuto beneficiare di una recitazione più vibrante e di una maggiore attenzione agli aspetti visivi.
Rosella Cutaia e Roozbeh Ranjbarian
di
Antonio Latella e Federico Bellini
Regia: Antonio Latella
Le attrici: Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara, Beatrice Verzotti
Costumi: Simona D’Amico
Musiche e suono: Franco Visioli
Movimenti: Francesco Manetti, Isacco Venturini
Produzione: TPE – Teatro Piemonte Europa
in collaborazione con Stabilemobile
DIALOGO “LA SCUOLA CATTOLICA” EDOARDO ALBINATI – “WONDER WOMAN” ANTONIO LATELLA E FEDERICO BELLINI
Abbandonarsi, uscire da noi stessi, diventare altro per ricucire i fili spezzati della Verità
Continua la lettura di DIALOGO “LA SCUOLA CATTOLICA” EDOARDO ALBINATI – “WONDER WOMAN” ANTONIO LATELLA E FEDERICO BELLINIDENTRO. UNA STORIA VERA, SE VOLETE – GIULIANA MUSSO
UNA NITIDA SPORCA VERITÀ
Squilla un telefono per qualche secondo, poi una voce registrata: «Vi siete spaventati? Pensavate fosse il vostro telefono, vero? Ecco, ricordatevi di spegnerlo» e un sorriso divertito da parte di tutto il pubblico del Teatro Astra. Inizia così lo spettacolo Dentro di cui Giuliana Musso è attrice, drammaturga e regista. Un’introduzione simpatica a un esercizio teatrale che invece vedrà uscire gli spettatori tutto fuorché alleggeriti.
Un pugno nello stomaco. Una verità che scuote.
Il palco si tinge di rosso: le sedie, l’illuminazione, il pavimento, tutto è rosso. Rosso è il simbolo della lotta alla violenza di genere, rosso il volto della rabbia provocata dall’ingiustizia, rosso è un urlo che non si censura più, che vuole farsi sentire.
Continua la lettura di DENTRO. UNA STORIA VERA, SE VOLETE – GIULIANA MUSSOIL TERZO REICH – CASTELLUCCI/SOCIETAS
Dal 25 al 27 ottobre 2023, al Teatro Astra di Torino, va in scena Il Terzo Reich, installazione audiovisiva di Romeo Castellucci, accompagnata dalla colonna sonora di Scott Gibbons. L’opera, che ha debuttato nel 2021, è ospite della programmazione della 28esima edizione del Festival delle Colline Torinesi.
Continua la lettura di IL TERZO REICH – CASTELLUCCI/SOCIETASSecond Look- 28° Festival delle Colline Torinesi
“Un altro sguardo”
Bisogna perdersi per ritrovarsi, talvolta ci si perde, però, nella speranza che possa trovarci qualcun altro, magari chissà, attraverso “un altro sguardo”, un Second look. Articolata in 10 cortometraggi, la proiezione di Second look attraversa la quarta parete come un proiettile, seguendo il file rouge di Hartaqat, con la prospettiva del dover “nascere due volte”. Un concetto che esprime una memoria costretta ad essere labile, talvolta inutile e che spesso, risulta appartenere più agli altri che a noi stessi. I ricordi costituiscono la nostra identità, quella di Rabih è stata in qualche modo profanata, il suo tentativo di raccogliere un gran numero di immagini, sembra restituirgli sembra restituirgli quella giustizia, per sè e per i soggetti ritratti nelle foto, che ha l’intenzione di sanare un vuoto che rimarrà incolmabile, un’esigenza, quella di Rabih, di collezionare quelle foto in bianco e nero, con cui crea un profondo legame empatico.
Lina Majdalanie e Rabih Mruoè sono due registi libanesi, naturalizzati francesi, coppia nel lavoro e nella vita ma sopratutto artisti, che oserei definire completi, per la maestria con la quale legano fra loro diverse arti, creando il proprio teatro contemporaneo. Utilizzando infatti strumenti, quali immagini, parole, musiche, strumenti musicali, luci, voci e proiezioni, miscelandoli armoniosamente. Un teatro il loro, di un impatto non indifferente, lo testimonia la quantità di pubblico che apprezza e lavora sulle loro opere, come hanno fatto Maddalena Giovannelli, Alessandro Iachino e Renato Palazzi, dedicandogli il terzo numero della trilogia Stratagemmi, della rivista Act. I temi sono spesso forti e profondi e per questo necessitano degli eventi collaterali del Festival delle Colline Torinesi, che aiutano a spiegarne gli intrecci ed i messaggi principali, seppur siano ben chiari nello svolgersi degli spettacoli.
Qual è il ricordo, del vostro percorso artistico al quale siete più legati? Questa è la domanda che ho posto ai due registi, al termine dell’ incontro al Polo del ‘900, il 12 Ottobre << ci sono tanti ricordi nel mio percorso artistico, non ho un’ottima memoria devo dire>> dice Rabih ridendo << penso però che di tutti questi anni, il ricordo più bello, sia stato quello di “far cambiare lo sguardo”>>. La risposta di Rabih chiarisce e rafforza ulteriormente l’obiettivo della loro arte, la quale, esercitata insieme o separatamente, ha l’obiettivo comune di regalare quel Second look, “altro sguardo” che li contraddistingue. Il profugo, tema chiave di questo 28° Festival delle Colline Torinesi, con paese ospite il Libano, è colui che fugge da una realtà crudele per la quale è costretto a rinunciare alle proprie radici, dovendosi sradicare da tutto ciò che gli è appartenuto fino ad allora, rifugiandosi in un nuovo paese che, al costo di perdere ciò che gli appartiene, possa donargli la libertà, sia essa fisica, morale o d’espressione. Lina Majdalanie e Rabih Mroué, in questa proiezione ci insegnano a parlare di noi stessi attraverso le esperienze di altre persone, con storie a noi simili o completamente diverse, ci insegnano a comunicare dolore, abbandono, giustizia, solitudine e seconda nascita oltre la lingua e le parole, attraverso l’immagine e l’immaginazione.
Episodio 1
Dal titolo Questa non è una metafora, il primo episodio ci regala subito un rumoroso silenzio, accompagnato da un piano a scorrimento orizzontale di due immagini sfocate, che appaiono inizialmente sovrapposte e la cui nitidezza è raggiungibile solo al termine del loro scorrimento. L’ immagine è ora chiara, i soggetti in primo piano sono sagome di edifici, un cielo limpido sullo sfondo, nuvole, le sagome sono nere, tutto appare fermo. Lo scorrimento sembra interpretare un viaggio, la confusione del percorso è forse rappresentata da queste immagini sfocate e sovrapposte che quasi faticano a distinguersi. Quando si raggiunge finalmente la chiarezza dell’immagine, si distingue il profilo di una città, chissà, forse Beirut. Gli edifici si distaccano dal fondale, iniziano a lasciare il terreno, si dirigono verso l’alto, vestiti di nero. Resta solo un limpido cielo azzurro, null’altro, ogni sagoma è scomparsa, ogni sagoma è forse un omaggio ad un’anima.
Episodio 2
Dal titolo Quando non eravamo ancora nati, il secondo episodio si apre con lo scorrere di una forma indefinita composta da immagini mescolate fra loro di varia natura. La ripresa rimbalza e sbatte sulle linee che determinano la forma indefinita, delimitando perciò lo sguardo dello spettatore anche attraverso restringimenti della ripresa. La “parola” è fondamentale in questa seconda parte in quanto dona la possibilità di immergersi completamente nella proiezione artistica, accompagnando il racconto visivo e perciò coinvolgendo maggiormente il pubblico oltre a creare una delicata empatia ed una calorosa accoglienza. << Colleziono le foto, ne colleziono di tutti i tipi, anche se preferisco quelle in bianco e nero, le colleziono per spiare le vite degli altri, appropriandomi di ricordi altrui e giustificandomi con il pensiero di salvarle>> questo dice lo stesso Rabih nel monologo originale poi doppiato da Marcello Spinetta in italiano. Visto da Lina come un profanatore di memorie, Rabih vuole forse solo proteggere ciò che gli è stato strappato via, i ricordi certo ma anche la sua storia, attraverso la conservazione di ogni volto impresso sulla carta. Storie mescolate, dettagli che distraggono e colori che si possono solo immaginare. Lo scorrimento termina con l’inquadratura di un uomo con una macchina fotografica, scontornato e su sfondo nero, che lascia poi spazio ad un allargamento della ripresa sulle stesse foto che compongono la forma indefinita, questa volta viste da lontano, sole, con le loro forme e la loro identità. Nessuna visione d’insieme << la storia non è un’isteria, per riuscire ad osservarla, dobbiamo esserne esclusi>> così dice Rabih.
Episodio 3
Il collezionismo nasce dalla volontà di proteggere delle storie o delle parti di esse, talvolta può però divenire la profanazione di queste, trattenendo nel tempo ciò che avrebbe il diritto di essere lasciato andare. << Lo trovo molto violento, non riesco a dimenticare che queste persone abbiano avuto una vita e con essa una privacy>> Lina Majdalanie, compagna di vita di Rabih, descrive con queste parole l’inquietudine del collezionismo e dichiara rivedendosi in esse :<<quando morirò voglio che le mie foto brucino con me>>. In Libano la cremazione è proibita, non si può decidere cosa fare del proprio corpo nemmeno di fronte alla morte, al medesimo modo solo i ricordi che portiamo nel cuore possono perire con noi stessi. Ciò che rimane di noi agli altri, finisce per non appartenerci più ed è così che essi possono disporre dei nostri ricordi nel miglior modo nel quale ritengano debbano essere trattati. Una consapevolezza tanto cruda non impedisce a Lina, in quella che riconosce come ipocrisia, di amare comunque quelle foto, sparse in ogni angolo di quello spazio che lei chiama “casa”. Non a caso il terzo episodio si intitola Perchè sono un’ipocrita. Su due bande laterali bianche, scorrono dall’alto verso il basso, foto scannerizzate, a destra la parte frontale e a sinistra il retro, cullate dalle parole di Lina doppiata dalla dolce voce di Francesca Bracchino: <<…lui pensa di essere un collezionista ma non lo è, sono anche io un’ipocrita ma mi consola il fatto che io ami le persone ritratte in queste foto, maledico il loro wellerismo, l’amore può essere letale qualche volta>> .
Episodio 4
Dal titolo Guardavo la foto che mi stava guardando con occhi lucidi, il quarto episodio, crea una profonda empatia tra collezionista e spettatore, facendoci entrare, pienamente, all’interno delle dinamiche che coinvolgono Rabih nella scelta dei volti appartenenti alla sua collezione di fotografie. Vagando per una città francese, Rabih si imbatte per caso in un banco di merce vintage, nel quale si distingue una scatola colma di foto. Attratto da un potente magnetismo e rapito da dettagli e colori, Rabih si accorge che quelle foto ritraggono tutte lo stesso uomo, in una foto indossa un giubbotto di pelle, ha occhi scuri, lucidi. In una lotta con la sua coscienza, il collezionista, prova con tutte le sue forze a non appropriarsi di una memoria che, ancora una volta, non gli appartiene. Il rispetto dell’identità di quest’uomo sconosciuto, gli impone di non rendere quelle foto oggetto della sua arte ma allo stesso modo di portarle con sé e proteggerle dal tempo << Qualsiasi cosa tu voglia fare di me non sarà più crudele di questo mercato>>. Il mercante era libanese, vendeva anche il giubbotto di pelle della foto. Il prezzo che ha accettato di pagare Rabih è quello di usare la sua lingua madre.
Episodio 5
Dal titolo Un fantasma seduto su una poltrona intento a guardare le sue foto, ci fa riflettere sul senso di una foto e sull’ironico paradosso di come esse alla fine non siano “utili” a nessuno. La ripresa si concentra sui dettagli di una foto antica, quasi a volerne scrutare ogni singola parte, come fosse un occhio: << I morti non hanno bisogno di foto […] o la vita torna indietro completamente o scompare, in entrambi i casi, sarebbero inutili […] riuscite ad immaginare un fantasma, seduto su una poltrona, che sfoglia un album delle sue foto? >>. Jeremy Bentham diceva che l’utile è ciò che produce un vantaggio, rendendo minimo il dolore e massimo il piacere. Il dolore di un’anima che ci lascia è inquantificabile e l’unica cosa che può ingannare il vuoto, diminuendo il dolore, è una fotografia.
Episodio 6 e 7
Dal titolo Vietato entrare e La stessa ansia, sono due cortometraggi molto brevi che raccontano, prima di Lina e poi di Rabih, del ruolo che i loro ricordi hanno nella loro vita e di quanta consapevolezza abbiano di essi. L’episodio sei è graffiante. Un manifesto strappato da un muro ormai rovinato è ciò che viene ripreso, una prospettiva dolorosa che visivamente ci restituisce subito il ruolo dei ricordi di Lina, rafforzato ulteriormente dalle sue affermazioni: << quando morirò voglio che tutto ciò che è mio venga buttato via, nel mare, è lì che riposeranno, in mare, qui i versi segreti non galleggiano ma affondano e per essere recuperati necessitano di pescatori esperti. Per fortuna sono pochi e dunque il mare è ancora pieno di segreti e lo sarà sempre.>> Segreti, i ricordi per Lina sono segreti, personali, delicati e privati, memorie che preferirebbe annegare piuttosto che abbandonare nella speranza che non finiscano nelle mani sbagliate, nel suo passato non si può accedere, è “vietato entrare”. Segue quindi il settimo episodio, scorre lenta la ripresa di fotogrammi, ognuno di essi rappresenta la stessa donna in primo piano, talvolta l’espressione del viso cambia e rende riconoscibili diverse emozioni, talvolta, risulta invece essere sempre la stessa espressione. Un suono profondo e vibrante apre il cortometraggio, l’angoscia, poi un armonioso arpeggio, ecco la consapevolezza: <<Man mano che passano gli anni, la mia storia diventa sempre più ordinaria, forse è perchè è accaduta solo a me. Diventano, quei ricordi, i personaggi principali, di un film che ho visto troppe volte, eppure non smette di fare male>>, il tempo passa per Rabih, il passato rimane immutabile e con esso i sentimenti che lo accompagnano, forse quelle foto vogliono arricchire questa storia “ordinaria” cercando di aggiungere o chissà, sostituire i personaggi ormai ridondanti di questo film che è la sua vita, una ricerca frenetica, continua che tenta di attenuare un’ansia perenne, “la stessa ansia” di sempre.
Episodio 8
Quello che succede quando nella vita quotidiana irrompe una guerra, lo spiega con una sorta di ironia Rabih Mroué in questo ottavo episodio dal titolo Il negozio di Constantine. Si dice: “l’insegnamento nel cadere sta nel ritrovare il modo di rialzarsi”, con queste parole si può riassumere la morale di questo cortometraggio, il quale ha l’intento di insegnarci l’arte del “ricominciare”. Una pellicola rotta apre il filmato, segue la ripresa di un televisore che manda in onda, quello che sembra essere l’atterraggio sulla luna. Rabih ha una grande famiglia i cui membri che la compongono sono 10. Abitano a sud di Beirut, la casa ripresa è quella dei suoi genitori e quella nel filmato è la loro televisione, la protagonista di questo racconto visivo. <<Era il 1967, zona Sud di Beirut, mio padre ha comprato la prima televisione, in due rate, al negozio di Constantine […] era il 1973, mio padre compra il secondo televisore, un proiettile bucò il primo […] era il 1982, un altro proiettile bucò il televisore, ne comprammo un terzo solo nel 1990, nel negozio di Constantine, non era più nel negozio di origine, si era spostato, per via della guerra>> questa linea narrativa adottata da Rabih, ripercorre i momenti più significativi della vita politica del Libano. La guerra inizia ufficialmente il 13 Ottobre del 1975, tuttavia erano già ampiamente presenti i conflitti nel paese, il primo proiettile che buca la tv risale infatti al 1973. L’ultimo proiettile bucò il televisore nel 1982 ma la scelta di acquistarne un terzo avvenne, come testimoniato dal collezionista, solo nel 1990, anno in cui viene dichiarata la fine della guerra in Libano. <<Ad un certo punto>> dice Rabih <<c’erano televisori in ogni stanza e solo i miei genitori a casa, con 5 tv>>, una metafora questa che con amarezza vuole raccontarci di come spesso, anche trovando la forza di ricominciare, attraverso sacrifici e valori, siamo circondati dal vuoto di ciò che ci è stato portato via: persone, sogni, ricordi: << Mio padre non ricorda nessuna di queste foto e neanche di averle scattate lui, eppure c’è scritto, è la sua calligrafia>>. Il loop di questo racconto ha scatenato reazioni di ilarità tra il pubblico, non le ho ben comprese, Rabih vive a Berlino, non ha nessuna televisione forse per far si che in questo modo, nessun proiettile possa bucarla.
Episodio 9
Dal titolo Le mie paure, i miei errori, nel breve seppur intenso episodio nove, parla per l’ultima volta Rabih, mettendo completamente a nudo la sua parte più fragile ed evidenziando il sentimento di impotenza che lo pervade facendolo sentire intrappolato << Ricordo errori e le circostanze in cui li ho commessi, eppure li ricommetto in circostanze simili[…] ha a che fare con il mio carattere, un carattere che non posso cambiare e se non riesco a cambiare me stesso come posso cambiare qualcosa del mio paese>>. In questo penultimo filmato viene ripreso un poster di carta, attaccato alla parete di un edificio che sembra abbandonato. Quest’ultimo sorge su una strada di periferia, un bambino gioca a pallone, non sembra aver alcuna attenzione per quel poster, in esso è raffigurata la sagoma di un uomo che appare elegante, ha un cappello, l’uomo è dietro delle sbarre, scalpita disperatamente, sembra chiedere aiuto in un grido che non può sentire nessuno.
Episodio 10
Chiude la proiezione artistica Lina Majdelaine con il decimo episodio intitolato M come malinconia, M come merda. << Quando avevo 14 o 15 anni, a scuola, la maestra ci chiese di fare un esercizio, coprire il sorriso di alcuni volti ritratti nelle fotografie guardandone solo gli occhi, ci chiese cosa vedemmo in esse, rispose lei, malinconia. Dopo anni ci ho riprovato, funziona ancora>>.
Second look è stata proiettato alla Fondazione Merz, che, allestita appositamente per ospitare presentazioni e spettacoli per il Festival delle Colline Torinesi, è in realtà una galleria d’arte, <<luogo di documentari, confini e sconfinamenti>> così definita da Alessandro Iachino, motivando la scelta di presentare alla stessa fondazione il volume della rivista Act dedicata a Lina Majdalanie e Rabih Mrouè. L’immagine è la protagonista indiscussa di questa serie di cortometraggi come lo è ormai diventata nella quotidianità, non solo per Rabih in quanto collezionista ma come artista e regista. La “picture” è un nuovo modo di comunicare, è potente e d’impatto ma soprattutto è immediata ed inclusiva ed è per questo divenuta la regina indiscussa della comunicazione, attraverso la rete internet, la pubblicità, la fotografia, l’arte e il teatro. Nella breve introduzione che precede la proiezione, Alessandro Iachino pone una domanda ai due artisti da sempre coinvolti nell’utilizzo eclettico dell’immagine come supporto per gli spettacoli.
Com’è cambiata la vostra storica relazione con le immagini? : <<Noi non siamo nati con i social media, oggi sappiamo quanto sia veloce e fondamentale l’immagine e per questo ci siamo chiesti, io e Lina, come portare questo a teatro. È una domanda a cui non ho risposta, poiché noi stessi ce la siamo posta. Proviamo, il cambiamento è necessario. Le immagini non hanno bisogno di parole, diventano o causa di grande odio o icone, simboli. Noi parliamo attraverso le immagini ed anche loro fanno lo stesso con noi, l’immagine è la condanna della parola, in essa c’è una completa assenza della verbalizzazione poiché contiene già un significato.>>: questo dice Rabih, riflettendo principalmente sul “come”. Lina invece, pone l’accento sulla responsabilità della memoria legata all’immagine: <<Nessuno può ricordare tutto ciò che è successo ma ognuno di noi ha la responsabilità di ricordare, seppur ogni memoria individuale sia edulcorata dall’immaginazione, rischiando perciò di dire il falso. La memoria si cristallizza, non è vera realtà>>.
Andy Warhol avrebbe detto “La cosa migliore di una fotografia è che non cambia mai, anche quando le persone in essa lo fanno.”, la rivista Act nasce dall’interrogativo dell’arte agente, l’arte che fa, l’arte che è e cambia le cose. L’arte può agire, agisce e può mutare ogni cosa ed è questo che ci hanno dimostrato Lina Majdalanie e Rabih Mrouè in questa proiezione, mutando ciò che di più personale ci appartiene, lo sguardo, trasformandolo in un Second Look.
Rossella Cutaia
Scritto e diretto da Lina Majdalanie e Rabih Mrouè
voice-over Lina Majdalanie e Rabih Mroué
animazione Sarmand Louis
editing Rabih Mrouè, Sarmand Louis
correzione fotografie Rafi Mrad
edizione italiana
traduzione Laura Bevione
voci Francesca Bracchino e Marcello Spinetta
registrazione a cura di Ruben Zambon
Coproduzione Festival delle Colline Torinesi\ TPE-Teatro Piemonte Europa
Benji … un’occasione perduta!
“Sono fuori di me e sono in pena, perché non mi vedo tornare”
(Luigi Tenco)
È complicato!
Questo spettacolo è complicato perché nasce come stand-up comica cucito su e per la sua ideatrice Claire Dowie, scrittrice, attrice, poetessa e pioniera dello stand-up theatre, una delle figure più anticonformiste del teatro contemporaneo che viene riadattato a monologo, tradotto e portato in scena da un numero ragguardevole di attrici che si sono cimentate con questo testo ma che non sono Claire Dowie.
Certo questo non vuol dire che chi non sia Claire Dowie non possa portarlo in scena ma… è complicato!
È complicato perché l’attrice, Olivia Manescalchi, è così brava da rendere molto credibile la sua interpretazione, così credibile da creare ancora più forte un cortocircuito con l’allestimento.

È complicato perché il personaggio in questione si rivolge direttamente al pubblico e comincia a raccontare una storia, la sua storia e anche se il personaggio in questione non ha un nome (Benji è il nome del cane della sua vicina e poi diventerà il nome con cui chiamare la sua amica immaginaria) lei rimane un personaggio che non diventa mai un narratore, checché se ne dica.
“Essere un narratore vuol dire un’altra cosa: è la base su cui costruiamo delle stratificazioni di comportamento per arrivare alla condizione di narratori ,che è una condizione stratificata. Non è che uno può improvvisare, prendere un libro e leggere e dice io sto narrando. La narrazione è fatta da una stratificazione dello stato di osservazione artistica. Come dice Benjamin, l’osservazione artistica porta una pulsione interiore in cui c’è l’incontro tra mente, cuore e braccio, che è l’atto del fare che trova uno stato divino in uno stato di consonanza che è stratificato. Non è che nasci così, lo devi accumulare, quando hai accumulato questi livelli di rapporti di consonanza tra il pensiero, il cuore, quindi l’emozione e la mente, allora tu ti muovi dentro una condizione in cui teatralmente è ridicolo parlare di personaggi […] Allora quando io dico narratore dico non interpretare. Prima di tutto, io come narratore ho una voglia, una voglia profonda che è una spinta propulsiva a dire del tutto che incontro…”. (Carla Tatò)
È chiaro che l’intento dello spettacolo di Benji non sia narrare ma interpretare ma ecco allora che ci scontriamo subito con un problema registico non di poco conto. Inoltre non darei così tanto per assodata la doverosa distinzione tra “narrare” e “interpretare”, se proprio legato a questo spettacolo sono stati pubblicati articoli con titoli come (valga uno per tutti): Il teatro di narrazione al teatro Argot Studio. Benji è il dramma della mancanza d’amore e di identità.
Ma perché deve essere, per questo spettacolo, più complicato che per altri?
Palcoscenico a vista completamente spoglio, a vista le quinte fuoriscena con corde e materiali teatrali, al centro del palco vuoto due sedie, una anonima, scura, di quelle pieghevoli e un’altra accanto più piccola rossa, una sedia da bambina. Comincia lo spettacolo e quasi non ce ne accorgiamo, c’è una dissolvenza di luci molto lenta che crea, in concomitanza con il procedere dell’attrice dal fondo buio al centro del palco, un cono di luce molto circoscritto al perimetro delle due sedie che delimiterà tutto lo spazio d’azione dello spettacolo. Uno spazio che dovrebbe essere angusto e claustrofobico, ma che dà anche l’effetto di una lente di ingrandimento, come se il personaggio sin da subito esponesse il suo corpo alla mercè degli spettatori in una sorta di confessione/inquisizione, qui il primo black out.

Quel tipo di confessione sarebbe stata più adatta al divano di uno psicoterapeuta che allo sguardo di un “pubblico”, che sia esso giudice o mero spettatore. Quelle sedie, se da un lato potrebbero persino far pensare a una situazione da gruppo d’ascolto, in realtà al tempo stesso lo contraddicono perché, per quanto anche noi siamo seduti, non ci sentiamo mai parte di un cerchio in intimità con il personaggio. Le sedie in scena del resto sono disposte su una fila retta parallela alla nostra, che crea ancora maggiore separazione tra noi e il mondo del personaggio, come se ci trovassimo su due schiere contrapposte. Quella confessione così intima, così credibile, fatta di micro movimenti nevrotici, dall’uso della sigaretta alla ricerca dei più svariati oggetti nella borsa, avrebbe avuto bisogno di una prossimità diversa. Si sentiva l’esigenza di un rapporto più intimo con quel corpo, che le parole del personaggio, a tratti sussurrate, ricercavano ma che l’impianto spaziale teatrale non consentiva. La stand-up comica di per sé nasce in un contesto di prossimità con il pubblico in un clima di convivialità dove spesso il pubblico beve e chiacchiera amabilmente, fino a quando il comico non cattura la sua attenzione. Qui per catturare la nostra attenzione c’è stato bisogno di una luce occhio di bue a pioggia che mette letteralmente sotto i riflettori l’attrice/personaggio.
Lorenzo Fontana, il regista dello spettacolo, utilizza la luce oltre che per delimitare lo spazio anche per scandire il tempo. Non ci sono particolari annotazioni musicali o effetti sonori, tutto si svolge su quella sedia su quell’unico corpo che viene esposto (al cono di luce) o nascosto (nel buio). Le scene hanno come unico raccordo il fuoco delle sigarette che l’attrice continua ad accendere una dietro l’altra.
C’è un solo momento in cui, e mi piacerebbe romanticamente credere che sia stata l’attrice più che il personaggio a prendere l’iniziativa di fuggire da quell’esposizione del cono di luce, in un moto di rivolta contro il regista che ha così “abusato” del suo corpo. In quella penombra limitrofa vediamo il riappropriarsi di una libertà nella gestione dello spazio, nel decidere cosa mostrare e cosa no, è il momento in cui il personaggio mima la distanza che separa la sua casa di infanzia dalla casa della vicina che aveva un cane che si chiamava Benji. In quel momento di “ribellione” il mio cuore ha avuto un sussulto, ho creduto che qualcosa accadesse, ma non appena l’attrice si è riavvicina a quel maledetto cono di luce, come risucchiata da una maledizione, il suo corpo viene nuovamente incatenato a quella sedia. Non saranno concessi altri momenti di libertà, anzi la scena divine sempre più piccola e il corpo si accartoccia fino a utilizzare come unico spazio esistenziale la seduta della sedia prendendo le distanze persino dal pavimento.
C’è un buon ritmo interno alla recitazione che non trova però una consonanza con il ritmo della regia che pretende di spiegare invece che mostrare, che riesce a essere ridondante nonostante il suo estremo minimalismo. Si può essere soli anche senza essere messi sotto un riflettore, si può avere un’amica immaginaria anche senza una sedia vuota a ricordarmelo.
Alla fine mi sono persa, non ho capito dove mi volessero condurre, ho trovato dissonanti il realismo dell’attrice con il linguaggio simbolico del regista, perché credo che, soprattutto per questo spettacolo, valga molto quanto afferma Carla Tatò:
“Perché spiegano… Se tu spieghi si perde la magia…. il problema è di andare veramente nell’evocazione dove ti perdi, ma sai quante volte io mi perdo e poi devo ritrovarmi […] Quando un attore è narratore invece che interprete per molti non è bravo, perché non ha quelle pause psicologiche, non ci sono, rompi tutto il tempo della descrizione psicologica del personaggio di cui tutti pensano che il pubblico abbia bisogno. Non è vero! Il pubblico non vuole descrizioni psicologiche, il pubblico vuole viaggiare, il pubblico è sensibile, vuole essere portato altrove e c’è una dinamica, c’è una dinamica che devi saper immettere per farlo viaggiare non è importante come finisce la storia, non gliene frega niente”.
Alla fine chi rimane incatenato alla sedia è lo spettatore che come il personaggio vede ridursi il suo spazio vitale sempre di più, sperando in viaggio che non ha mai inizio, che occasione perduta!
Nina Margeri
Al Teatro Astra di Torino Benji di Claire Dowie
con Olivia Manescalchi
regia di Lorenzo Fontana.