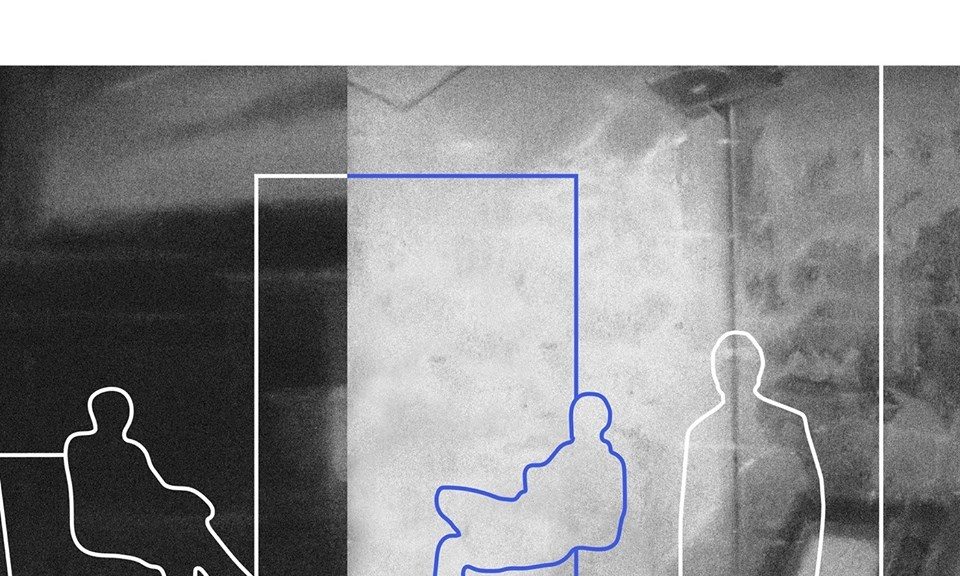Ascanio Celestini, figura di spicco della narrativa italiana, ha portato in scena uno spettacolo dalla struttura per lui tipica. Tre storie apparentemente banali; estratti di vita quotidiana di una periferia romana: la storia di una commessa, di una barbone e di un facchino nero.
Continua la lettura di PUEBLOArchivi tag: Teatro Gobetti
Matilde e il tram per San Vittore
Il sipario è aperto quando ci sediamo in platea. Delle grandi e alte lastre di ferro sovrastano il fondo del palco in una fila orizzontale che sembra infinita, e in mezzo alla scena vediamo solo un tavolo con due panche, anch’essi di ferro. L’atmosfera è quindi fredda, pesante, inquietante, come lo è il tempo in cui saremo catapultati a breve.
Del resto siamo in una fabbrica, e l’ambiente non può altro che essere grigio e opprimente. Ce lo rivela la prima attrice che entra in scena, iniziando a raccontare la storia dei tre grandi scioperi partiti dalle fabbriche di Milano dal 1943, durante la seconda guerra mondiale. Migliaia di operai, stanchi delle condizioni di lavoro inumane, della fame, della vita che stavano conducendo sotto la scure fascista, si ribellano con fierezza alla logica della guerra: se non si fabbricano più le armi, forse anche la guerra finirà. A seguito dello sciopero del 1943 ce ne furono altri due, nel ’44 e nel ’45: una lenta marcia verso la deportazione e la morte per centinaia di operai.

Presto scopriamo che le attrici in scena saranno tre, ma le anime a cui daranno voce sono molte di più: tratto dal libro Dalla fabbrica ai lager di Renato Sarti, lo spettacolo rende giustizia alle storie delle donne, madri, figlie, sorelle degli uomini deportati nei campi nazisti, che prendono vita attraverso l’impeccabile performance artistica di Maddalena Crippa, Debora Villa, Rossana Mola: emozionanti, emozionate, ci trasportano in un epoca buia con le loro parole e azioni taglienti come lame.
Le vicissitudini di queste famiglie si susseguono senza sosta, dando vita a un puzzle che sembra quasi impossibile: la paralisi dei grandi stabilimenti del milanese porta alla paura di essere trovati dalla polizia nazifascista, allo smarrimento di non sapere che fine abbiano fatto i propri uomini.
Poi c’è la speranza di poterli rivedere, di potergli portare vestiti e viveri prima che siano trasferiti a “lavorare” in Germania: là fa freddo, ci ricordano le voci che aleggiano come fantasmi disperati intorno a noi, ed è necessario riuscire a portare ai cari in partenza almeno il cappotto. La frenesia del viaggio attraverso le stazioni lombarde di queste donne viene resa perfettamente dalla recitazione che si fa sempre più ritmata, come una marcia, quasi esasperata, fino ad arrivare alla partenza del treno, verso una meta ignota. Tante donne non erano nemmeno riuscite, nella calca impazzita, a salutare i figli, i mariti, i fratelli, a dargli il maglione o il tozzo di pane che avevano preso repentinamente da casa prima di andare di corsa alla stazione più vicina per raggiungerli.

E tante donne non parleranno nemmeno più con i loro familiari, amici: l’ultima parte dello spettacolo è infatti dedicata alle storie di chi non è più tornato, del vuoto che ha lasciato nel cuore e nelle case di molte famiglie. Ma anche a chi è riuscito a tornare, e negli occhi e nel cuore non ha più avuto lo stesso vigore con il quale era partito: uomini che non riusciranno mai a esprimere la sofferenza che hanno visto e vissuto sulla loro pelle, ma che ogni notte piangeranno in silenzio accanto alle mogli apparentemente addormentate.
Notevole la regia, che attraverso le luci ha esaltato perfettamente i sentimenti di panico, dolore, paura, smarrimento provati dalle tante donne che hanno avuto il coraggio di raccontare la loro storia. Inoltre è stato dato grande rilievo alla componente uditiva, soprattutto durante i racconti delle retate notturne nazifasciste: grazie all’uso abile delle componenti scenografiche in ferro, le attrici riuscivano a far emergere, almeno in parte, quella che doveva essere la confusione e il terrore dato anche dai forti rumori e suoni che rimbombavano nella notte silenziosa.

Una Resistenza, quindi, narrata in modo commovente dal punto di vista femminile di donne forti che si sono trovate improvvisamente a gestire situazioni impensabili, di violenza, miseria e dolore. Come ricorda infatti il regista Renato Sarti: “Fin dalle tragedie greche la voce delle donne è quella che meglio di ogni altra riesce a rievocare l’orrore della guerra, che sempre nuovo, purtroppo, si ripete”.
Di Alice Del Mutolo
di Renato Sarti
dal libro di Giuseppe Valota Dalla fabbrica ai lager
con Maddalena Crippa, Debora Villa, Rossana Mola
regia Renato Sarti
scena e costumi Carlo Sala
musiche Carlo Boccadoro
luci Claudio De Pace
progetto audio Luca De Marinis
dramaturg Marco Di Stefano
Teatro della Cooperativa
sostenuto da NEXT 2017/18 – Regione Lombardia con il patrocinio di ANPI, Istituto Nazionale Ferruccio Parri
e ISEC e dei comuni di Albiate, Bresso, Cinisello Balsamo, Monza e Muggiò con il sostegno di ANED
La ballata di Johnny e Gill – Fausto Paravidino
Una linea sottile orizzontale, l’universo appiattito, come in un buco nero. L’assenza di tempo e spazio. Una visione dall’alto che è anche visione senza tempo, al di sopra di tutto, primigenia e pura. La fine e l’inizio del mondo. L’anima che si fa Assoluto. Con questi presupposti, lo spettacolo crea il mondo, mondo in cui la necessità, l’imperativo morale è la migrazione. Mondo in cui si erge incontrastata e solinga la torre di Babele, monito del peccato di ubris dell’uomo. Segno della dispersione dell’uomo, diviso in lingue diverse. Gli uomini tutti fratelli, ben presto si dispersero, chiusi nella loro incomunicabilità, divennero estranei. Ma al centro di tutto c’è sempre un uomo, un uomo qualunque non un santo: Abramo, a cui Dio, dà il compito terrificante di andare a conoscere gli altri uomini. Abramo lascia tutto e parte, non importa se spinto davvero da Dio, o semplicemente dall’impellenza o necessità di viaggiare e conoscere l’altro. Da qui ha origine la nostra civiltà, una civiltà di migrazione continua. La necessità di cambiare la propria condizione esistenziale e materiale verso una terra promessa.
“Vattene dal tuo paese, dalla tua patria / e dalla casa di tuo padre / verso il paese che io ti indicherò”, il Signore ad Abramo.

Fausto Paravidino, il Dramaturg del Teatro Stabile di Torino, mette in scena in qualità di regista e sceneggiatore, oltre che attore, lo spettacolo La Ballata di Johnny e Gill. Uno spettacolo diverso da quelli in cui siamo soliti imbatterci, se bazzichiamo tra le sue opere. Non più i kitchen sink drama degli esordi, da qualche anno Fausto Paravidino fa del teatro diverso, un teatro sempre contemporaneo, che guarda all’attualità per abbracciare tutto quello che offre, quindi anche il suo passato, la Storia tutta. I Fenomeni che vediamo non sono nuovi, ma repliche di azioni che abbiamo già fatto anni addietro. E allora viene spontaneo partire dalla Bibbia, testo cardine della nostra civiltà, testo che ci culla di nascosto fino al contemporaneo.
Lo spettacolo è una fiaba di qualcosa che non capiamo, con cui non riusciamo a fare i conti. La storia è costruita per quadri, riuniti parzialmente da delle dissolvenze in nero. Johnny e Gill sono italiani, sebbene non lo si dica apertamente. Vendono il pesce, ma non sono soddisfatti della loro condizione. Johnny, dopo uno strano sogno con uomini mascherati, forse emissari del Signore o semplicemente incarnazioni dei suoi turbamenti interiori, prende la moglie Gill e l’amico Lucky e decide di andare via dalla sua terra. Attraversano diversi luoghi, emblema di tutte le migrazioni passate e future, luoghi che portano con sé i mali dell’uomo che non ha ancora accettato la diversità di Babele. Quindi il deserto con le sue carestie e i suoi predoni/terroristi, sciacalli perversi che spolpano la vittima lasciandola in agonia ad assaporare la sua vacanza spirituale tra la sabbia. I soldati corrotti, che invece si divertono a macerare ulteriormente questa carne sopravvissuta al deserto. E infine il mare, calma piatta di una tempesta in agguato. Sale, arsura, onde. Ma dov’è la terra promessa? Eccola! L’America, luogo della mente. Dove tutti sognano di andare. Paese dei Balocchi, dove i sogni saranno realtà. La massiccia immigrazione italiana in America in anni forse dimenticati di proposito, se si nota con quanto odio accogliamo oggi lo straniero. La xenia, l’ospitalità dell’antica Grecia. Era un dovere sacro per i greci ospitare chi chiedeva l’ospitalità. L’America che ci accoglieva, magari non per dovere, ma accoglieva. Cosa che oggi, pare, si sia persa nei meandri della storia, sia America come in Italia.

Johnny e Gill si scontrano con culture e lingue diverse , si sentono estranei. Gli attori nello spettacolo parlano inglese, francese e grammelot. La lingua può essere un ostacolo ma quando c’è volontà di capire, la si capisce. Dio ha punito gli uomini costringendoli a parlare diversamente, ma in questo spettacolo e sia all’esterno di esso, nel mondo delle migrazioni, c’è la necessità di ricongiungere quello che è stato diviso. Johnny e Gill, in questa nuova terra, fanno quello che sanno fare meglio: vendono il pesce. Incontrano il boss locale, ottengono il suo rispetto. Imbattersi nel boss locale, se si apre un’attività nella zona controllata da questo individuo, è un’usanza, un rito. Zeus proteggeva i viandanti, la xenia, Zeus Xenios. Ora a proteggerli c’è il Padrino. Nonostante gli imprevisti la loro attività avrà successo, ecco l’America che dà possibilità, il sogno americano. La loro vita scorre in parallelo a quella di Abramo: Gill/Sara non potrà avere figli e per questo tentano la strada dell’utero in affitto. Da Agar, la donna che si presta a ciò e che ha lo stesso nome anche della schiava di Abramo, nascerà il loro bambino, Ismaele. La gelosia tra Gill e Agar porterà all’allontanamento di questa e del bambino non riconosciuto. Spetterà ad un tassista vestito da Babbo Natale, annunciare la venuta di un bambino: “ Avrete un bambino, ma ricordatevi, donando la vita si dona la morte, il figlio sarà vostro ma non vi apparterrà: un giorno dovrete restituirlo”. Questo Dio camaleontico infonde speranza in ogni cosa. Ecco il bambino, ecco Isacco. Nella nostra epoca un sacrificio di un figlio come sarebbe possibile e visualizzabile? C’è sempre un sacrificio all’angolo della strada. La guerra, la patria che sacrifica i suoi figli, il figlio che torna allo zio Sam che lo richiede. La guerra in Iraq dopo gli attentati di Al-Qaeda, si presta ad inglobare i figli della terra. Ecco il sacrificio. Ma come Dio salva Isacco, anche il figlio di Johnny e Gill è salvo dalla guerra, così continueranno la loro vita in pace.

La guerra e le migrazioni sono fondamentali per capire il nostro tempo, per individuare il punto da sanare che è lì visibile e aspetta solo la cessazione di queste oscenità. Le persone scappano dalle guerre, dalla povertà, da condizioni esistenziali inaccettabili e ha il diritto di farlo, di migliorare la condizioni. Queste persone lasciano tutto per l’ignoto, per una fede in qualcosa che spesso idealizzano, il paradiso ci sarebbe, ma noi abbiamo deciso di chiuderlo, i porti sono chiusi. Noi abbiamo invece il dovere di accogliere, la xenia dovrebbe essere normale, la regola. Le migrazioni sono anche un fenomeno culturale, un fenomeno per ricongiungere i popoli, per riconoscersi attraverso le diversità. Questo lo spettacolo mette in scena con ironia beffarda e riso ammiccante. La fede, la necessità di poter cambiare di senso la torre di Babele, da monito di peccato a un peccato di ubris ancora maggiore, ma bello: la voglia di accogliere e comprendere il diverso. A noi non ci resta che avere fede nei pesciolini gialli: quando siamo tristi pensiamo a loro.
Emanuele Biganzoli
Testo e regia Fausto Paravidino
Ideazione Iris Fusetti e Fausto Paravidino
con Federico Brugnone, Iris Fusetti, Fatou Malsert, Daniele Natali, Tibor Ockenfels, Fausto Paravidino,
Aleph Viola
scene Yves Bernard
luci Pascal Noël
video Opificio Ciclope
costumi Arielle Chanty
maschere Stefano Ciammitti
musiche Enrico Melozzi
coreografia Giovanna Velardi
aiuto regia Maria Teresa Berardelli
Le Liberté, scène nationale de Toulon, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, La Criée – Théâtre National de Marseille, Pôle Arts de la Scène
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
ARTE La verità di una tela bianca
Al Teatro Gobetti di Torino, giovedì 15 e venerdì 16 marzo, è andato in scena Arte della drammaturga francese Yasmina Reza, diretto dalla regista esordiente Alba Maria Porto e tappa conclusiva del progetto “Arte: Dialoghi in Contemporanea”.
Serge, Marc e Yvan – interpretati rispettivamente da Christian La Rosa, Elio D’Alessandro e Mauro Bernardi – sono tre giovani che si conoscono dai tempi della scuola, che hanno condiviso scelte e gusti, ma che si sono allontanati in età adulta, separati da differenti obiettivi e sensibilità. La storia comincia quando Serge acquista per 200.000 euro un quadro totalmente bianco, gesto che provoca ilarità, ma anche sgomento nei due amici, specialmente in Marc. La loro amicizia è messa a dura prova da quelle che, all’apparenza, sembrano semplici divergenze d’opinione, ma che, con il progredire dello spettacolo, trovano ragioni più profonde. I tre personaggi inevitabilmente s’interrogano sul senso del loro rapporto, su un’amicizia che sembra basarsi solo sul ricordo del legame che li univa nel tempo lontano della scuola, e che ora si ritrovano perché Yvan ha chiesto agli amici di un tempo di essere i testimoni alle sue nozze, programmate per il giorno dopo.
L’immagine chiave del testo è quella del labirinto, in cui discussioni che sembrano sul punto di spegnersi vengono riaperte e rilanciate, in un ribaltamento continuo del punto di vista. A differenza di Il dio del massacro (diventato un successo internazionale grazie alla versione cinematografica diretta da Roman Polanski intitolata Carnage), Arte osserva i personaggi sotto una luce più marcatamente ironica, intrecciando momenti di riflessione e situazioni apertamente comiche. Sia per l’efficacia del testo, sia grazie agli interpreti, che si dimostrano in grado di cambiare pelle e adattare i toni e i sentimenti alle situazioni, lo spettacolo procede senza fare mai cadere la tensione, tenendo viva l’attenzione fino al momento finale.
Il labirinto trova il suo centro (che apre e chiude la pièce) nel dipinto.
La tela bianca, o meglio il concetto di arte che essa rappresenta, è il pretesto per far emergere le relazioni, le aspettative disattese, le illusioni, i diversi ego che cercano di imporsi sugli altri, le prese di posizione rispetto alle cose che accadono. La questione del punto di vista è resa dalla regista attraverso una scelta minimalista e austera per quanto riguarda scene e costumi. Tutto ciò che è in scena ha un valore. Gli abiti permettono allo spettatore di cogliere fin da subito l’indole dei personaggi. Yvan è l’unico dei tre che non presenta un colore dominante e il cui abbigliamento, abbastanza sciatto, segnala la scarsa capacità di gestire la propria vita e di avere una opinione propria, indipendente da quella degli amici. Serge, invece, ha un aspetto più raffinato, da artista, veste – in accordo con il suo dipinto – con tonalità chiare, che alludono a una sorta d’innocenza e a un ottimismo quasi infantile. Infine, Marc indossa un completo nero e una camicia viola scuro che rispecchia il suo atteggiamento nichilista e non di rado sarcastico. L’abitazione in cui si svolge la vicenda è allusa mediante un’impalcatura di luci al neon, scelta calzante per evitare soluzioni naturalistiche e valorizzare al massimo la parola del testo e l’interpretazione degli attori.
Come i tre personaggi che vedono nella provocazione del dipinto verità diverse, gli spettatori sono messi a loro volta di fronte al quadro bianco per trarne una verità, non assoluta, ma valida per loro. Poiché, parafrasando Herman Hesse, “di una storia è vero solo quello che lo spettatore crede”.
Riccardo Ezzu
Arte
di Yasmina Reza
nuova traduzione Luca Scarlini
con Mauro Bernardi, Elio D’Alessandro, Christian La Rosa
regia Alba Maria Porto
scene e costumi Lucia Giorgio
in collaborazione con gli allievi dell’Accademia Albertina di Belle Arti
musiche originali Elio D’Alessandro
progetto video Indyca
un progetto di Alba Maria Porto, Annalisa Greco, Claretta Caroppo
in collaborazione con Il Mulino di Amleto, Tedacà
e con ERT per la residenza a Villa Pini
partner The Others Art Fair, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Brevidistanze
si ringraziano l’autrice Yasmina Reza
e Dominique Christophe Laboratorio Artistico Pietra
realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ORA! Linguaggi contemporanei, produzioni innovative”
Diario di una Tirocinate – Don Giovanni
Cari lettori, vi scrivo per raccontarvi un’esperienza unica!
Ho la fortuna di fare un tirocinio presso il Teatro Stabile di Torino, e non negli uffici, ma svolgendo un lavoro dall’interno di in uno degli spettacoli che si prospetta tra i più interessanti della stagione: Don Giovanni per la regia di Valerio Binasco. Subito dopo il primo incontro con Valerio Binasco in quattro e quattr’otto mi sono ritrovata al tavolo con tutti gli attori il primo giorno di prove.
Ufficialmente alle 14.39 di Lunedì 26 febbraio, si è partiti in q

uesta avventura. I primi due giorni, siamo stati ospitati al Gobetti in sala Pasolini, perché alle Fonderie Limone faceva troppo freddo e nessuno si deve ammalare! Per me e la mia compagna di avventura ed amica, Giada, i primi giorni ci sono serviti per capire con chi avevamo a che fare, che tipo di lavoro sarebbe stato il nostro. Seppur un pochino spaesate, fin da subito Valerio ci ha integrato in tutto e per tutto nell’organico presentandoci a tutta la compagnia.
A metà settimana poi ci siamo spostati alle Fonderie, ed aspettando che la scenografia fosse pronta, gli attori hanno iniziato ad alzarsi dal tavolino e a provare con movimenti, in sala K.
E’ molto interessante vedere, giorno dopo giorno, come i personaggi prendono vita e ognuno degli attori ci mette se stesso. Binasco è molto attento a non togliere la naturalezza propria di ogni attore, e senza che vi sveli troppo, lo vedrete maggiormente nel secondo atto, che nel caso di alcuni personaggi è stato riscritto in dialetto.
I problemi ci sono stati in queste prime due settimane di lavoro, uno su tutti l’impatto con la scenografia: si tratta di una compagnia che in passato ha lavorato molto a tavolino e in movimento (provando e costruendo le scene in spazi più piccoli e creando insieme una scena collettiva che fosse la stessa nell’immaginario di tutti).
Questo maggiormente si è verificato per il secondo atto, ambientato in un piccolo Bar. Ogni attore vi vedeva un bar differente. Il problema ha trovato la sua soluzione quando gli attori si sono seduti e hanno raccontato cosa fosse per ciascuno quel luogo, spostando gli attrezzi di scena, vivendolo per davvero e affrontando lo spazio, senza paure.
Adesso si sta procedendo in maniera spedita a montare i vari atti, i costumi sono in v ia di rifinitura, le musiche sono sempre più precise e le luci vanno a scolpire i sentimenti dei personaggi.
ia di rifinitura, le musiche sono sempre più precise e le luci vanno a scolpire i sentimenti dei personaggi.
Nel frattempo, noi suggeriamo, corriamo a destra e sinistra per fare in modo che non manchi mai nulla e scriviamo i vari rapporti di giornata.
Come sta andando, cosa sta succedendo….? Lo saprete tra una settimana.
Blogger in incognito, Elisa Mina
IL BALLO
Un’attrice, 5 voci, tanti specchi.
Sonia Bergamasco porta sulla scena del Teatro Gobetti una favola nera di Irène Némirovsky, scrittrice francese di origine ebraica vittima dell’olocausto.
E’ la storia di Antoniette, una ragazzina quattordicenne, figlia di ebrei arricchiti, trascurata da una madre troppo narcisista ed egoista per preoccuparsi di lei.
Finalmente la madre ha ottenuto la ricchezza tanto desiderata e può permettersi di dare il primo ballo, che le aprirà le porte al suo debutto in società. Ma Antoinette viene esclusa: non può parteciparvi, e tanto meno rivolgere la parola a qualcuno. Chiusa in camera. Quello è il suo posto.
La ragazza allora compie il suo atto di vendetta: in un attimo d’ira getta nel fiume gli inviti, così che nessun nobile lo riceverà mai.
E’ il giorno del ballo: il tavolo è imbandito con pietanze di ogni tipo, la sala addobbata a festa, l’orchestra pronta per suonare. Ogni cosa è predisposta per accogliere la più alta società.
Ma non arriva nessuno. Solo la vecchia cugina, presenza non gradita dalla madre, ha ricevuto il biglietto a mano, e si trova ad essere partecipe di quest’immensa umiliazione.
Di fronte alla disperazione, la figlia, col viso nascosto tra le braccia della madre in lacrime, ride. La vendetta è stata compiuta.

Sonia Bergamasco porta in scena con un’interpretazione magistrale il racconto in tutta la sua spietatezza, dando voce ai 5 protagonisti: Antoinette, la madre, il padre, l’educatrice e la vecchia cugina.
Come scrive la stessa Bergamasco è una storia “di vendetta e di disamore; (..) il teatro di un bambino solo che costruisce il suo mondo, perchè il mondo conosciuto (quello degli adulti) non è bello e non gli piace”
Ed è questo che noi vediamo: una figura esile e bianca, che si muove sola, in un palcoscenico pieno di specchi, in cui si è costretti a guardare e guardarsi: in cui madre e figlia sono costrette a rispecchiarsi.
Ma la storia di Antoinette è molto più di questo: “è l’arma di vendetta di una scrittrice che sempre, in ogni sua opera, ricorda e non perdona. La scrittura come arma, scoperta molto presto da Irène, proprio contro quella famiglia, quella madre che non aveva saputo amarla.”
Lara Barzon
Racconto di scena ideato e interpretato da Sonia Bergamasco
liberamente ispirato a Il ballo di Irène Némirovsky
disegno luci Cesare Accetta
scena Barbara Petrecca
costume di scena Giovanna Buzzi
Teatro Franco Parenti / Sonia Bergamasco
Muttersprache Mameloschn – Lingua madre Mameloschn: alla ricerca della propria dimensione.
Non tutti siamo fatti per restare dove siamo nati: c’è chi, allora, parte e rispetta l’intenzione di non tornare più, chi parte ma torna indietro quasi subito, e chi, come Rahel, figlia di Clara e nipote di Lin – le tre protagonista di questa dramma- salpa alla volta di New York per iniziare un nuovo capitolo della propria vita, portandosi dietro un amuleto pesante di confusione storica, di ricordi e di fragilità.
Si sa, all’inizio è sempre allettante trasferirsi in un posto nuovo ma poi, piano piano, subentrano le difficoltà; la vita, infatti, sa essere crudele e mette a durissima prova l’essere umano.
Rahel, inizialmente, gode della sua confusione a proposito delle vie senza nomi ma solo numerate; è felice di tornare a sentirsi nuovamente come una sorella minore- come scrive nelle lettere rivolte al fratello assente- e di non capire la lingua del posto: un’incomprensione linguistica che ricorda tanto Alexander Bruno, il protagonista di un libro di J. Lethem , che cerca a tutti i costi di andare in posti esotici in cui la lingua a lui sconosciuta lo lasci felicemente ISOLATO nell’incomunicabilità; ma se per questo protagonista il tutto si rivela come un dolce balsamo, per Rahel, invece, a lungo andare, diventa estenuante.
“Io non capisco i piccoli dettagli, le allusioni, non capisco nemmeno le barzellette, niente!” scriverà al fratello, in modo sempre più disperato. Le barzellette che strappavano risate dolci-amare, le barzellette simbolo di casa, simbolo di una lingua parlata da sempre con sua madre e sua nonna, una lingua madre appunto -un mameloschn– che ora ha perduto e non sa come ritrovare.
Sentirsi continuamente fuori posto, affermare la propria identità mediante la storia passata e ricercare una propria lingua madre in cui sentirsi a casa: sono questi i temi di un dialogo politico, religioso, familiare ed intimo che le straordinarie Elena Callegari, Francesca Cutolo e Maria Roveran portano in scena con tenerezza, passione e delicatezza.

È intorno al tema della partenza, però, che si snoda l’intero dramma. Il primo a essere andato via e a non aver fatto più ritorno è Davie, unica figura maschile dell’intero dramma che presenta la sua assenza unicamente con delle lettere spedite alla sorella Rahel, dalle quali si alzerà il coro delle voci della coscienza delle donne, con un sistema narrativo che ricorda il romanzo La grande sera di Pontiggia. Seguirà poi, la partenza della giovane ragazza, che segnerà un ennesimo colpo al cuore per una madre ormai “orfana” di due figli.
Partire, dunque, per cercare di risolvere le questioni in sospeso o addirittura lasciarle alle spalle, ma è davvero sempre possibile? Il poeta latino Orazio, in un famoso esametro, diceva che è il cielo a mutare per coloro che attraversano il mare, e non l’animo; lo stesso vale per gli affanni dell’anima dell’adolescente, che non riuscendo a superare il dolore causato dalla partenza definitiva dell’ amato fratello maggiore, prova a superarla attraverso una partenza in un nuovo Stato -che comunica allo spettatore attraverso un intimo monologo- ma nemmeno a lei è dato da sapere se riuscirà nel suo intento: quando il dolore c’è e non passa, te lo porti dietro ovunque, anche dall’altra parte del continente!
Oltre alla figura pregnante della ragazza, protagoniste di questo dramma sono, poi, altre due donne, altre due generazioni che sono l’una l’antitesi dell’altra: una nonna e una figlia- a sua volta madre di Rahel- che ne hanno vissute tante insieme, dagli spettacoli di cabaret alle manifestazioni socialiste guidate dall’ormai anziana Lin e , tutt’ora, si ritrovano a (soprav)vivere con tutte le loro contraddizioni, in un vortice di amore e odio, in un appartamento berlinese, all’ombra della caduta del Muro.
Si amano, si uccidono con una mezza parola che è peggio di una freccia imbevuta nel veleno, come solo una madre sa lanciare…e ancora si amano e si disprezzano e più si amano e più si rinfacciano i dogmi di un ebraismo ormai diventato un peso per entrambe. Tentano, invano, di lasciarsi ma non riescono a stare l’una separata dall’altra, sono l’una l’ossigeno per l’altra; solo la morte sarà in grado di separarle, ma solo apparentemente poiché un filo rosso le terrà per sempre unite.
Sasha Marianna Salzmann è nata nel 1985 a Volgograd nell’Unione Sovietica, vive tra Berlino e Instanbul, è scrittrice e curatrice del teatro Maxim Gorki di Berlino, ed è l’autrice di questo dramma, la cui regia è stata curata da Paola Rota, attrice di cinema e teatro, nonché regista di spettacoli prodotti dal Teatro Stabile di Torino, della Biennale di Venezia e del Teatro dell’Elfo di Milano.
Martina Di Nolfo
di Sasha Marianna Salzmann
traduzione Alessandra Griffoni
con Elena Callegari, Francesca Cutolo, Maria Roveran
regia Paola Rota
costumi Ursula Patzak
luci Camilla Piccioni
Teatro Stabile di Genova
Festival delle Colline Torinesi
PAV nell’ambito di Fabulamundi .
Playwriting Europe – BEYOND BORDERS?
con il supporto del programma dell’unione Europea Creative Europe e del Goethe Institut
LE BARUFFE CHIOZZOTTE, UNA COMICA MALINCONIA CON INTERVISTA AD ANGELO TRONCA
Le Baruffe Chiozzotte, regia di Jurij Ferrini, è in scena al Teatro Gobetti di Torino dal 21 Novembre al 17 Dicembre 2017.
Il famoso testo di Carlo Goldoni, uno dei più divertenti scritti dall’autore, ritrae l’atmosfera della vita popolana del Veneto del ‘700: uomini un po’ rozzi, istintivi, bloccati nel rispetto dell’onore e delle tradizioni, prima fra tutte il matrimonio, che è il motore centrale che governa tutte le azioni dei personaggi. Ci sono cinque donne che cuciono merletti in attesa del ritorno degli uomini, in attesa di essere chieste in spose: due di loro sono già maritate e fanno quasi da madri alle altre tre ragazze che non vedono l’ora di andare in spose all’uomo che più le affascina. E da un piccolo corteggiamento mal riuscito scaturisce la grande baruffa che porterà tutti i personaggi di fronte alla legge: Isidoro, interpretato dal regista, è il cogitore veneziano che non solo riuscirà a portare la pace tra le due famiglie in litigio, ma combinerà anche i tre matrimoni.

La traduzione in italiano dell’opera, scritta in dialetto veneto, restituisce alla perfezione il ritmo originario e rende comprensibile a tutti la storia. L’unico a parlare in dialetto (che in realtà si trasforma in una lingua inventata splendidamente comica e incredibilmente chiara a tutti) è il personaggio di Fortunato (Angelo Tronca). Tutti gli attori hanno ottimi tempi comici e usano il corpo in armonia con lo spazio. I personaggi sono dipinti con affetto, sono tutti simpatici e in fondo al loro cuore buoni, con valori puri nella loro semplicità; ognuno di loro è ben tratteggiato, e soprattutto i personaggi femminili hanno una personalità definita e forte. Infatti, sono loro a causare e alimentare i litigi, mentre gli uomini sembrano quasi marionette mosse dalle gelosie e dalle chiacchiere femminili.

Questa commedia però non è solamente risate e ironia, racchiude un nucleo problematico e malinconico, come rivela lo stesso regista. Parla, infatti, di uomini che stanno dieci mesi in mare, facendo una vita molto dura e tenendo in pensiero i loro cari rimasti a casa. Le fanciulle sono ossessionate dal matrimonio, visto più che come un momento gioioso, come un modo per andarsene di casa. Per sposarsi basta darsi la mano, gesto che può diventare meccanico, come meccaniche e ripetitive appaiono le vite di questi giovani. Inoltre, mancano figure genitoriali di riferimento, sebbene siano poi gli uomini più maturi a cercare di far ragionare tutti e a voler riportare la serenità.

Interessante la scelta di Ferrini di trasporre la vicenda in un contesto meta teatrale: stiamo infatti assistendo a una prova aperta, non esiste la quarta parete né l’illusione del teatro, solo un abbozzo di scenografia. I costumi sono normali abiti di tutti i giorni, anche se ogni attore ha uno stile che lo differenzia dall’altro e che richiama il carattere del proprio personaggio. A ricordare l’epoca storica di questa commedia stanno dei manichini sullo sfondo vestiti con abiti settecenteschi. Così il passato e il presente si fondono nelle Baruffe senza tempo.
di Carlo Goldoni
traduzione Natalino Balasso
con Jurij Ferrini, Elena Aimone, Matteo Alì, Lorenzo Bartoli, Christian Di Filippo, Sara Drago, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Rebecc a Rossetti, Michele Schiano di Cola, Marcello Spinetta, Angelo Tronca, Beatrice Vecchione
regia Jurij Ferrini
scene Carlo De Marino
costumi Alessio Rosati
luci Lamberto Pirrone
suono Gian Andrea Francescutti
regista assistente Marco Lorenzi
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale
di Alice Del Mutolo
INTERVISTA AD ANGELO TRONCA
Oggi è qui con noi Angelo Tronca, un attore che ha collaborato con il teatro Stabile di Torino interpretando il personaggio di Fortunato nello spettacolo. Insieme a lui, cercheremo di capire meglio il suo ruolo, la sua formazione e le sue passioni.

intervista a cura di Alessandra Nunziante
ELEPHANT WOMAN: LA PISTOLA DELLA FOLLIA
Un altro spettacolo del ricco programma del Festival delle Colline Torinesi 2017: Elephant Woman, di Andrea Gattinoni con Silvia Lorenzo, in scena al Teatro Gobetti.

La scena è completamente vuota: quinte e fondale neri e una luce fissa. Nel buio sentiamo un rumore di tacchi a spillo, poi entra una donna con un rossetto rosso, seminuda, che inizia a parlare di sé, Topazio, e della sua amante, B. Dopo pochi minuti ci da le spalle ma, girandosi di nuovo, ci punta addosso una pistola: proprio questo oggetto sarà il punto di tensione di tutto lo spettacolo, perché il pubblico non riuscirà mai a staccare gli occhi dall’arma e, proprio per la sua presenza, non abbasserà mai l’attenzione nemmeno per un secondo.
Topazio è una giovane donna che decide di abbandonare famiglia, lavoro e amicizie per vivere ai margini della legalità e per dare sfogo a ogni pulsione. Il racconto procede con l’attrice sempre al centro della scena. Si muove lentamente e, nonostante sia sola, non fa mai sembrare vuoto il palcoscenico. Ci cattura con la mimica e con il corpo, con la voce suadente e con i racconti della sua vita: una vita di dolore, di abusi, di solitudine e di insicurezza.
Per tutto lo spettacolo abbiamo l’impressione di trovarci all’interno della mente un po’ malata di Topazio: i suoi racconti provengono dal buio, da un incubo, e non saremo mai sicuri della veridicità delle sue parole. Ma non è questo l’importante, non è necessario sapere se siano tutte bugie o se sia un sogno. Il testo, infatti, vuole farci riflettere sul doloroso destino di alcune donne maltrattate e poi abbandonate a loro stesse. Questo non può far altro che creare esseri umani che non distinguono più la realtà dalla finzione e finiscono per relegarsi ai margini della società.
Il perno emozionale dello spettacolo è la lettura di una lettera alla madre, che non ha mai aiutato la figlia abusata dal padre: la disperazione, il dolore e la follia che ne deriva si scatenano come una tempesta, amplificata dall’uso di un microfono panoramico.
L’attrice Silvia Lorenzo è stata in grado di tenere alta l’attenzione degli spettatori per un’ora di monologo. Alla drammaticità dei racconti si sovrappongono momenti comici in cui l’attrice ripete a memoria definizioni tecniche della lingua italiana o astronomiche come se fosse una voce automatica, esterna al personaggio.

Un colpo di pistola sottolinea il termine dello spettacolo, facendo domandare a tutti gli spettatori se Topazio si sia uccisa, se abbia ucciso qualcuno, o se sia mai esistita.
Alice Del Mutolo
di Andrea Gattinoni
regia Andrea Gattinoni
con Silvia Lorenzo
produzione Teatro Filodrammatici, Festival delle Colline Torinesi
Teatro Stabile di Torino stagione teatrale 2017-18, conferenza stampa
Giovedì 11 maggio presso il Teatro Carignano si è tenuta la conferenza stampa del Teatro Stabile di Torino riguardante il programma della stagione teatrale 2017-18 . Sono intervenuti il presidente Lamberto Vallarino Gancia, il direttore Filippo Fonsatti, il direttore artistico Mario Martone, il nuovo direttore artistico che entrerà in carica dall’inizio del 2018, Valerio Binasco, le assessore alla cultura Francesca Paola Leon e Antonella Parigi e Barbara Graffino, membro del consiglio generale della Compagnia di San Paolo.
Il presidente Lamberto Vallarino Gancia ha espresso, a nome suo e del Consiglio di Amministrazione, i più sinceri auguri al nuovo direttore artistico Valerio Binasco, ai collaboratori dello Stabile e a Mario Martone, per l’ottimo lavoro che ha svolto negli ultimi dieci anni. Ha introdotto poi il direttore Filippo Fonsatti, ricordando quanto sforzo comporti creare un cartellone teatrale come quello dello Stabile e ha mostrato gli indicatori chiave della stagione scorsa. Lo Stabile di Torino si conferma al secondo posto tra i Teatri Nazionali nella classifica ministeriale grazie ad un’alta qualità dei progetti artistici, al contributo economico garantito dai Soci Aderenti e soprattutto grazie al lavoro svolto dallo staff.
La cultura è fondamentale per la crescita di un territorio. La nuova stagione comprenderà 16 produzioni, di cui 5 nuove produzioni esecutive, 6 nuove coproduzioni e 5 riprese, tra cui 29 spettacoli ospiti e 24 spettacoli programmati per la rassegna Torinodanza. Sono 69 gli spettacoli con grandi titoli di registi e attori che si sono affermati sulla scena scena nazionale e internazionale. Tra le produzioni troviamo molte rivisitazioni di testi classici: Don Giovanni di Molière con la regia di Valerio Binasco, Le baruffe chiazzotte di Carlo Goldoni con la regia di Jurij Ferrini, L’illusion Comique di Pierre Corneile con la regia di Fabrizio Falco e Le Baccanti di Euripide con la regia di Andrea De Rosa. Ma troviamo anche una vasta gamma di produzioni contemporanee come Il sindaco del rione Sanità di Eduardo De Filippo con la regia di Mario Martone, Il nome della rosa di Umberto Eco con la regia di Leo Muscato, L’Arialda di Giovanni Testori con la regia di Valter Malosti, Galois di Paolo Giordano con la regia di Fabrizio Falco, Emone. La traggedia de Antigone seconno lo cunto de lo innamorato di Antonio Piccolo con la regia di Raffaele Di Florio e Da questa parte del mare di Gianmaria Testa con la regia di Giorgio Gallione. Prosegue la collaborazione con le compagnie teatrali della città di Torino: importante la coproduzione di Lear, schiavo d’amore dei Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa che debutterà in prima nazionale al Teatro Gobetti con la regia di Marco Isidori, inoltre anche Mistero Buffo di Dario Fo prodotto dal Teatro della Caduta con la regia di Eugenio Allegri, Alice nel paese delle meraviglie prodotto dal Mulino di Amleto con la regia di Marco Lorenzi e La bella addormentata con la regia di Elena Serra.
Il teatro pubblico non è la casa di un singolo artista, è un cantiere aperto dove i registi al lavoro devono essere numerosi e diversi tra loro, con un orizzonte comune ovvero la direzione artistica per evitare che gli spettacoli siano un assemblaggio di merci su uno scaffale. Per questo nella stagione prossima si punterà ad una riflessione su temi del nostro mondo complesso, dal micro al macro, della dimensione sociale mononucleare a quella di massa destinato a raggiungere la dimensione G-zero. Ad esempio con il pluripremiato Disgraced di Ayad Akhtar, in cui fuoriesce la tensione culturale all’interno del salotto borghese, con la regia di Martin Kušej.
Tra i dati riportati da Filippo Fonsatti è importante sottolineare che tra il 2015 e il 2016 c’è stato un aumento del 85% delle vendite dei biglietti e che purtroppo quest’anno ci sarà un aumento dei prezzi, eccetto che per gli studenti. Si è parlato molto anche di giovani, infatti Lo Stabile collabora con la Scuola di formazione per Attori e ben 128 artisti e tecnici sono under 40 e altri 45 sono under 30. Perché il teatro comprende tutti coloro che lavorano al suo interno, non solo gli attori ma anche i tecnici che lavorano dietro le quinte.
Inoltre c’è il desiderio di variegare le fasce di spettatori, comprendendo molti giovani e offrendo la possibilità a un pubblico di estrazione sociale e di grado di istruzione diversi fra loro di dialogare, perciò assieme alla Fondazione CRT, il Teatro Stabile offre gratuitamente 1.000 abbonamenti per cittadini a basso reddito.
A seguire è intervenuto Mario Martone, presentandosi per l’ultima volta pubblicamente come direttore artistico e lasciando in eredità il suo ruolo al successore Valerio Binasco, regista e attore tra i più apprezzati e premiati della scena italiana. Martone ha sostenuto che il teatro è una macchina che ha bisogno di una buona conduzione gestionale, dove è importante l’elemento razionale ma anche una certa imprevidibilità e follia degli artisti. La parola è poi passata a Valerio Binasco che si è presentato entusiasta di continuare a lavorare con solidità e coerenza sulle tracce del collega Martone, con attenzione ai temi della contemporaneità riletti in modo innovativo ed originale, prestando attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti. Durante il suo intervento ha sottolineato quanto sia importante che il teatro rifletta e si interroghi sulla realtà che ci circonda.
“Il teatro non è un semplice luogo dove si svolgono le rappresentazioni teatrali ma è un luogo di vita quotidiana.” ha aggiunto Barbara Graffino, che è intervenuta assieme agli assessori.
Resoconto scritto da Floriana Pace e Andreea Hutanu.
TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE
@Presidente: Lamberto Vallerino Gancia
@Direttore: Filippo Fonsatti
@Direttore artistico: Mario Martone
@Consiglio d’Amministrazione:
Lamberto Vallerino Gancia
Riccardo Ghidella (Vicepresidente)
Mario Fatibene
Cristina Giovando
Caterina Ginzburg
@Collegio dei Revisori dei Conti:
Luca Piovane (Presidente)
Flavio Servato
Stefania Branca
@Consiglio degli Aderenti:
Città di Torino
Regione Piemonte
Compagnia di San Paolo
Fondazione CRT
Città di Moncalieri (Sostenitore)
INFORMAZIONI. Biglietteria del Teatro Stabile di Torino: Teatro Gobetti, via Rossini 8 – Torino. Tel. 011 5169555 – Numero verde 800.235.333 – info@teatrostabiletorino.it